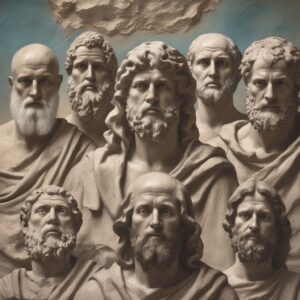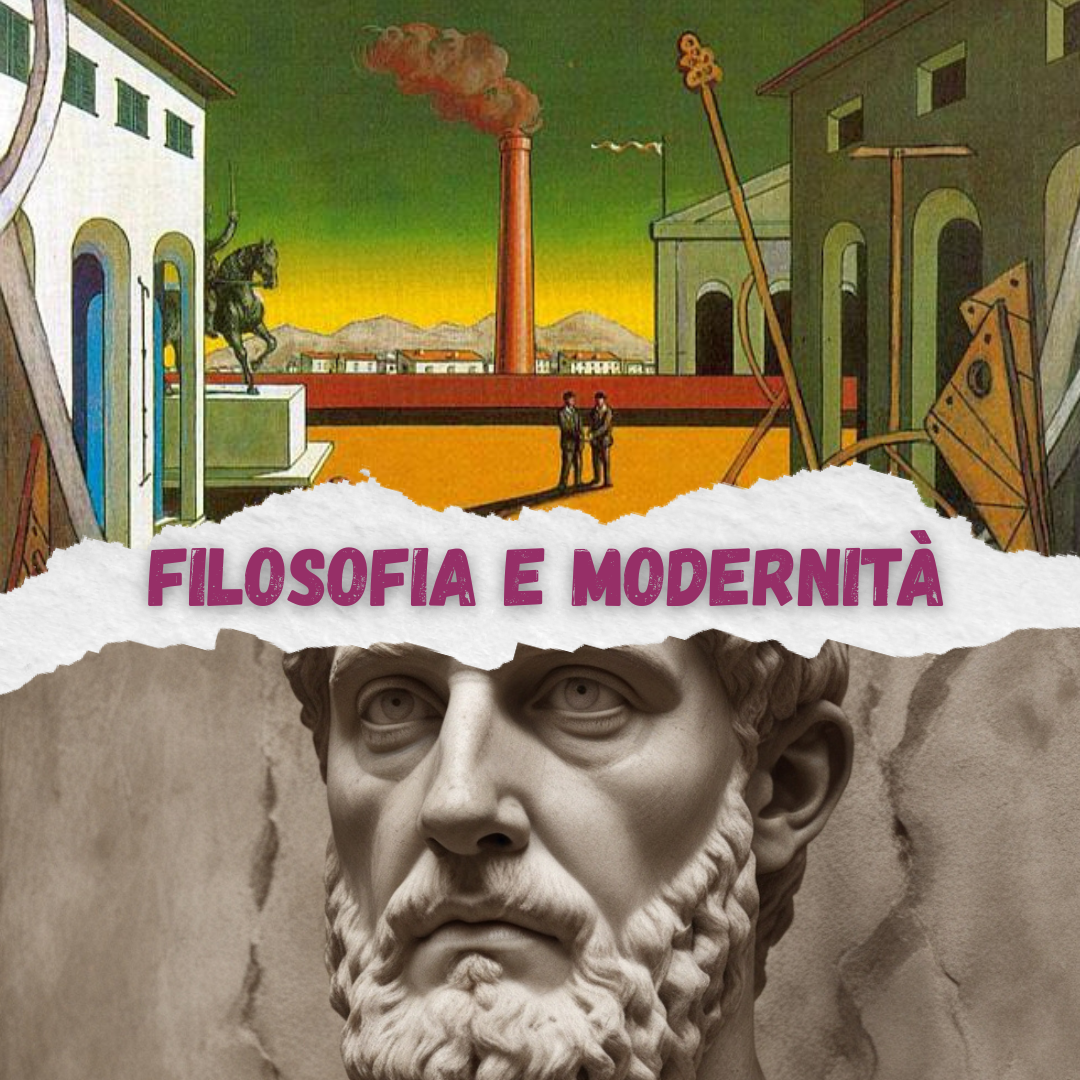Uno scritto di Lisa Casagrande.
Nel VI secolo a.C., nelle città ioniche e in particolare a Mileto, l’atmosfera dinamica e intraprendente che si sviluppa nelle diverse Πόλεις favorisce la nascita e lo sviluppo di un nuovo modello di sapere che si affianca a quello religioso: la filosofia (φιλιά – σοφία) .
Essa nasce nel momento in cui l’uomo (ό άνθρωπος) , osservando la realtà circostante, si interroga su quale sia l’elemento comune a tutte le cose. Le risposte a cui giunge nel corso del tempo sono molteplici e diverse. Tuttavia, durante l’età classica si possono individuare alcuni elementi comuni nelle ricerche dei diversi filosofi. Il processo di conoscenza è sempre in stretto rapporto con l’elemento metafisico, la natura e l’uomo. Questi vengono indagati come creature derivate dal dio, secondo quelli che sono gli aspetti qualitativi della realtà:
– La forma,
– La materia,
– Il fine per cui una cosa esiste e la sua causa,
– Il luogo in cui giacciono, ecc.
Lo studio della natura conduce dunque sempre all’individuazione di una realtà altra, ultraterrena, come si evince dal pensiero di Parmenide, Platone e Aristotele.
L’Umanesimo e il Rinascimento
Nell’ambito della società urbano-borghese si verificano determinate condizioni sociali e mentali atte a favorire la nascita di una nuova cultura: la cultura umanistico-rinascimentale, che riflette a livello teorico il mutato atteggiamento dell’uomo rispetto al mondo e alla vita.
L’uomo rinascimentale è assolutamente poliedrico:
1. L’importanza per la cultura,
2. Il ruolo centrale del soggetto e della ragione nel processo di conoscenza,
3. Il nuovo rapporto uomo-Dio sono aspetti centrali della filosofia del tempo.
Un esempio significativo è il pensiero politico: in questo ambito si sente il bisogno di individuare uno Stato laico, ma le risposte sono differenti: così da una parte, il realismo politico di Machiavelli, che si concentra sulla “verità effettuale della cosa”, definendo un modello statale libero dalla morale e dalla religione.
Dall’altra, la riflessione di Tommaso Campanella, che nell’opera “La Città del Sole” teorizza uno Stato ideale, in cui la pace, la tolleranza, la giustizia sociale e un rapporto armonico con la natura sono sovrani.
Durante il Rinascimento vengono ampiamente riprese le due principali filosofie classiche:
– L’aristotelismo,
– Il platonismo, che ebbe particolare successo grazie all’Accademia Fiorentina di Marsilio Ficino. Quest’ultimo, per rinnovare la saldatura tra religione e filosofia, fece ricorso proprio al pensiero platonico.
Tra i filosofi neoplatonici si distingue anche Niccolò Cusano, il quale introdusse due concetti fondamentali che influenzarono notevolmente la filosofia successiva:
– La dotta ignoranza,
– La coincidentia oppositorum.
Riguardo al primo, Cusano sostiene che la conoscenza si determina solo dove c’è proporzionalità tra ciò che il soggetto conosce e ciò che si deve conoscere. Egli afferma che l’essenza di Dio non si rivelerà mai interamente agli uomini, poiché si manifesta attraverso le sue opere, ma al contempo si ritrae, celando la sua intima sostanza. Basandosi su questa concezione, affine alla teologia negativa, l’uomo non può giungere alla conoscenza di Dio, poiché non esiste una proporzione tra Dio e la ragione umana. L’atteggiamento corretto da assumere è quello di una consapevole ignoranza: l’uomo deve accettare di non poter cogliere Dio in tutta la sua magnificenza, ma questa stessa coscienza lo spinge a una continua tensione ed elevazione verso la conoscenza divina. Questa ricerca, seppur infinita, lo porterà a migliorare e ampliare il proprio sapere, proprio come un poligono iscritto in una circonferenza che, pur aumentando illimitatamente i propri lati, non si sovrapporrà mai ad essa.
Sincretismo e natura nel Rinascimento
Un altro aspetto fondamentale della filosofia rinascimentale è l’idea di un’unica rivelazione eterna. Giordano Bruno e Marsilio Ficino considerano la nascita di un determinato sapere religioso come un percorso che parte da Mosè, viene trasmesso da Platone e giunge fino ai loro giorni, costituendosi come un vero e proprio sincretismo tra filosofia e religione.
Anche la natura acquista un nuovo valore in età rinascimentale. Essa viene indagata secondo i suoi principi propri, come affermava Telesio. L’indagine naturale si sviluppa attraverso la trasformazione e la rielaborazione metodologica della magia e della filosofia naturale, entrambe basate sulla convinzione che nella natura siano iscritte leggi affini a quelle della mente umana.
L’Umanesimo e il Rinascimento si costituiscono pertanto come la base teorica della rivoluzione scientifica, avviata da Galileo Galilei e Francis Bacon. Essi individuano un metodo oggettivo alla base della filosofia moderna, sempre più orientata verso la matematizzazione e la soggettivizzazione del reale.