Hierapolis Finalmente
Andrea Soppelsa
Lo immagino così l’inizio dell’evento, in un giorno qualsiasi sul finire del Quattorcento : vento gelido proveniente da nord, occhi socchiusi, nel vano tentativo di proteggersi , e mani e braccia congiunte in un abbraccio come unico riparo possibile, al momento, per un corpo troppo esposto alla forza vitale degli elementi.
In quella posizione, dall’alto di un lembo di terra che, cadendo giù in verticale nel vuoto andava ad infrangersi lungo la linea schiumosa e irregolare di un azzurro mare intenso, si ricordò di aver sentito parlare una volta di un disegno dove, all’interno di un quadrato i cui vertici erano inscritti all’interno di una circonferenza, era inserita una figura umana che, nella sua interezza, risultava essere sovrapposta a sé stessa.
Si sentiva così, come la parte nascosta dell’uomo vitruviano, solo un po’ più timido e introverso, quasi fosse il suo contrario, o , per meglio dire, il suo rovescio.
“Hierapolis, finalmente !” annota, con grafia incerta, nel diario delle sue memorie, accarezzando lentamente le sue ruvide pagine. “ Ricordo ancora vividamente il giorno in cui partecipai al mio primo grande caso: attendevo sonnacchiosamente ad una lezione d’anatomia del mio maestro, Guido, presso la sua abitazione, allorché un uomo, per conto di Piero de’ Medici, venne a chiamarci, essendosi improvvisamente aggravate le condizioni di salute del Magnifico. Tanto grande era, nella città dell’Alighieri, la fama di cerusico del mio precettore.
Dunque, ci recammo ad Artimino, ove, poche ore prima, Lorenzo era stato trasportato. Tuttavia, per quanto avessimo spronato i nostri destrieri, quando giungemmo alla villa Medicea di Careggi, non trovammo l’uomo, ma solo un corpo esanime, attorniato dai lamenti funebri delle donne e dal ricordo delle gesta compiute in vita.
Era il tramonto dell’8 aprile 1492 e, colui che governa la morte, Θάνατος , conduceva con sé il più grande esemplare che la stirpe umana avesse generato nel secolo decimo quinto. Era il tramonto di un’epoca per l’Italia: privata del suo “Ago”, diventò ben presto terreno di conquista per le grandi potenze straniere. Ma, in quel momento, eravamo lontani dal meditare tutto ciò.
I
PARTE PRIMA: Di come effettuammo l’autopsia e di ciò che si scoprì in séguito ad essa.
Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi;
oggi siam, giovani e vecchi,
lieti ognun, femmine e maschi;
ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non v’è certezza.
(Lorenzo de’ Medici, “Il trionfo di Bacco e Arianna”)
Tra gli affranti presso la proda del letto del defunto, riconobbi in prima parte colui il quale in quel tempo vagheggiava l’ideale della pax philosophica : messer Pico della Mirandola. L’autore del “ Oratio de hominis dignitate” ,nel quale egli affermava che l’uomo è tutto e niente, ovverossia che esso è un’opera di natura indefinita (come mi aveva istruito il mio precettore), sedeva accanto a un misero fraticello, completamente assorto nelle sue preghiere. Se egli non si fosse vòlto verso di me, non avrei sicuramente riconosciuto in lui il vólto di quel folle predicatore, Girolamo Savonarola, sebbene fossi presente la mattina del 27 aprile dell’anno precedente, quando, durante una cerimonia religiosa, all’improvviso, salì sul pulpito e fece una terrifica predicatio , atterrendo la folla presente. Oggi, rispetto ad allora, appariva macilento e smunto, quasi fosse consunto da una grave colpa interiore. < Maledetto frate!> proruppe subitaneamente il segretario del Magnifico, appena pervenuto nell’alcova funebre,< Voi, coll’anatema che gli avete scagliato e con le vostre nefaste predizioni , voi siete la causa del decesso del nostro signore !> .
Savonarola arretrò, ed ora si appoggiava ad un religioso, mentre il suo viso era stato inondato da un pallore diffuso, come coloro che percepiscono avvicinarsi inesorabilmente la loro ultima ora . Il Poliziano proseguì con le sue invettive:< frate del demonio, simoniaco, stregone, vedrete che presto i vostri patti siglati col diavolo chiederanno in cambio l’anima dannata di Girolamo Savonarola! >. A quel punto, un frate dello stesso convento del ferrarese lo invitò ad abbandonare il luogo e la calma fu ristabilita.
La salma venne trasferita in un’oscura stanza delle cantine, nella quale il mio maestro aveva allestito un gabinetto di anatomia, con i mezzi necessari a un esame post-mortem. < Vedi, mio fedele discente, oggi eseguiremo una autopsia con tecnica autoptica. Sai, forse, in quale occasione venne eseguito per la prima volta questo tipo di esame ?>.
< Non ne ho idea, maestro> risposi. < Bene. Cominceremo, quindi, con alcune nozioni storiche; prendi nota nel tuo taccuino: come ci informa Svetonio, il primo esame autoptico fu eseguito dal medico Antistio sulla salma di Giulio Cesare dopo la sua uccisione da parte dei congiurati alle idi di marzo del 44 a.C. In seguito non venne più svolto, fino a quando Federico II istituì la prima cattedra di anatomia presso la Scuola Medica Salernitana-luogo in cui, come ben sai, io stesso ho studiato- e questa tecnica venne riscoperta.> Fece una pausa, poi proseguì:< Ora ti illustrerò i mezzi utilizzati: questa è un enterotomo> sollevò delle grandi forbici < grazie a questo pallino metallico è possibile salvaguardare la mucosa dell’intestino durante l’apertura del medesimo.
Questa sorta di pinza, invece è un forcipe, utile per sollevare i tessuti. Con la sega, invece, si tagliano le ossa e , dulcis in fundo, il frangicoste > mi mostrò un utensile simile a delle cesoie < Esso è lo strumento che consente l’asportazione del piastrone sternale per l’esplorazione della cavità toracica, mediante vari tagli che vengono effettuati sulle costole lungo il margine cartilagineo, dove il taglio risulta essere più netto e preciso, mentre se fatto direttamente sull’osso è probabile che si formino delle schegge, che possono essere dannose per le mani che andranno poi a esplorare la cavità toracica. Hai capito ?> <Credo di sì> risposi.<Molto bene ! Comunque, ago e filo è l’essenziale per compiere un’autopsia, ricordalo, dato che, se intraprenderai quest’arte, potresti trovarti a svolgere autopsie in condizioni difficili, privo degli arnesi che ti ho esposto in precedenza>. < Me ne ricorderò> lo rassicurai. < Non manca nulla, ergo, possiamo iniziare. Avvicina il lume>.
L’esame si protrasse per tutta la durata della notte. < Ebbene, cosa avete scoperto?> domandai io.< I miei peggiori timori erano fondati: Lorenzo de’Medici non è deceduto per la gotta, ma è stato avvelenato!> rabbrividii< Ne siete certo?> chiesi io < Purtroppo sì. Vedi, l’epitelio enterico distaccato e la formazione di vescicole al di sotto della mucosa sono un chiaro sintomo di avvelenamento da arsenico; prendi nota, l’arsenico elementare venne isolato per la prima volta da Alberto Magno nel 1250.> <In che modo può essergli stato somministrato l’arsenico senza che egli ne avesse cognizione ?> di fronte a questo quesito, il mio precettore tacque per qualche secondo, poi sentenziò:< Domanda acuta. Sfortunatamente, in questo momento non sono in grado di risponderti…solitamente l’arsenico viene ingerito per via orale, essendo insapore, inodore e incolore; dunque, teoricamente, l’assassino, o gli assassini, avrebbero potuto diluirlo nell’acqua, non destando alcun dubbio né in Lorenzo né in coloro che gli stavano accanto. Sarà il caso d’informare Piero de’Medici del risultato dell’autopsia. Andiamo!>.
II
PARTE SECONDA: Colloquio con Piero de ’Medici.
« Natura non produrrà mai più un simile uomo »
(Caterina Sforza, signora di Imola, appena seppe della morte di Lorenzo il Magnifico)
Fummo accolti in uno studiolo; una grande tela di Luca della Robbia raffigurante la flagellazione di Cristo attirò la mia attenzione, non appena varcata la soglia. Invece, alzati gli occhi, fui sorpreso dalla maestosità del soffitto in legno intarsiato. Un gradevole aroma di rosa selvatica proveniva dalle finestre aperte che davano sul giardino. Era la primavera e con essa, la natura si apprestava a compiere l’eterno ed incessante miracolo della rinascita. Così, al pari dei gigli che, rifiorendo, schiudono il loro bocciolo, le bestie che, durante l’inverno vanno in letargo per fuggire il gelo e la penuria di cibo, disserrano i loro occhi. Piero de ‘Medici ci ricevette intento a redigere una lettera. La sua mano, impugnante una penna d’oca, si muoveva alacremente, seminando inchiostro sul foglio bianco. < Ebbene, messer Guido, di quale delle plurime malattie di cui soffriva è morto mio padre? Di gotta, forse, oppure a causa dell’ulcera che lo opprimeva da qualche tempo? > domandò, < Vedete Piero, il vostro illustre genitore non è deceduto per nessuno dei mali che avete elencato, ma…> s’interruppe un istante, come per raccogliere le forze necessarie per riferirgli la nostra scoperta, < …Ma per aver ingerito una dose letale di Arsenico>. Piero trasalì. Una macchia d’inchiostro cadde sull’epistola. < Ne siete certo ?> chiese il nuovo signore di Firenze. < È così, purtroppo !> rispose rammaricato il mio maestro. Seguì un silenzio assordante rotto solamente dalla pispilloria cagionata da uno stormo di passeri che avevano il loro nido in uno dei cipressi del giardino. Piero chiuse le finestre. < Mio padre è stato assassinato !> realizzò, < Ma chi può essere il suo carnefice ? Egli aveva molti amici in Firenze, ma, anche, molti nemici. Credetemi, Guido, se vi dico che mi è davvero difficile ipotizzare chi sia l’omicida>. <Lo posso immaginare, tuttavia, dato che i primi sintomi di avvelenamento da arsenico si manifestano una manciata d’ore dopo essere stato assunto, è sufficiente che mi aiutiate a ricostruire le ultime ore di vita di Lorenzo, dalla sera del 7 aprile > rispose il mio precettore. < Dunque, quella sera eravamo proprio qui, alla villa di Careggi; messer Pico della Mirandola aveva indetto un banchetto in onore dell’anniversario della fondazione dell’Accademia neoplatonica. Oltre a mio padre e a me, vi parteciparono Marsilio Ficino, lo stesso Pico, il segretario di Lorenzo, Angelo Poliziano e il Savonarola. Dopo questo, siamo ritornati in città, a palazzo Medici, e lì ha svolto le sue normali faccende, trai suoi doveri e le donne> concluse il figlio del Magnifico. < Secondo voi, chi, tra i presenti alla cena, aveva una ragione per ucciderlo ?> lo interrogò il mio maestro. < Senza dubbio, nell’ultimo anno, egli era entrato spesso in conflitto col Savonarola, il quale in più occasioni gli aveva predetto la morte; per quanto riguarda gli altri, che io sappia, non vi erano che dei normalissimi screzi, nulla di rilevante>. Il mio precettore rifletté un momento, quindi sentenziò così:< Credo che, per qualche tempo, sia opportuno mantenere il massimo riserbo circa la causa della morte di Lorenzo; diremo che è perito per un’ulcera malcurata. In questo modo potrò condurre delle indagini senza che l’omicida si allarmi e occulti eventuali prove della sua colpevolezza. Siete d’accordo?>, < Da parte mia non c’è alcuna obiezione> confermò Piero,< Ma siete certo che costui (indicò me), del quale ignoro il nome, mantenga la dovuta discrezione ?>. < Senza ombra di dubbio, messere> ribatté Guido, < Questo giovane si chiama Giulio Lami ed è il mio discepolo prediletto. Credo proprio che mi sarà di grande aiuto nelle indagini che mi appresto a svolgere>.
Ci congedammo.
III
PARTE TERZA: primi sospetti e sospettati
“Qualsiasi evento storico, per quanto nefasto possa essere, è sempre posto su di una via che porta al positivo, ha sempre un significato costruttivo.”
(Sant’Agostino)
Mentre ritornavamo presso l’abitazione-scuola riconoscibile per i mattoni in opus spicatum, le ipotesi e i dubbi occupavano i nostri dialoghi:< Credete che quel predicatore ferrarese sia stato capace di tanto ?> domandai, < Ne dubito; in primo luogo, perché sarebbe stato un gesto sciocco e avventato, dal momento che tutti sono a conoscenza del fatto che gli aveva predetto la morte; in secondo luogo, per il semplice motivo che il quinto comandamento della sua religione gli impone di non uccidere. Ciò non toglie che, nel meriggio, ho intenzione di andare a fargli visita al convento di San Marco>. E così fu. Suonata la campana all’entrata, si affacciò all’uscio un frate al quale chiedemmo di essere ricevuti dal priore, Savonarola appunto. Ottenemmo una risposta positiva, anche se ci chiese un certo tatto, dal momento che, come asseriva lui stesso “ il nostro fratello Girolamo è molto scosso dalla morte di messer Lorenzo, poiché in un certo qual modo, si sente colpevole per avergliela predetta”. Savonarola stava pregando nel chiostro di San Domenico. < Fratello, permette che vi rivolga una domanda ?> disse Guido, < Se avete anima di parlare con un peccatore della mia risma, si> rispose.< Siete stato voi ad uccidere Lorenzo de’ Medici ?>. < Ebbene si, sono stato io ad ucciderlo, e solo Iddio sa quanto me ne penta>. Io e il mio precettore ci guardammo stupefatti, poi Guido: < Davvero, siete stato voi ad avvelenarlo ?>. <Avvelenarlo?> negli occhi del Savonarola si leggeva la sorpresa< come avvelenarlo? Io mi riferivo al fatto di non avergli concesso il conforto della mia benedizione, non certo ad una simile barbarie; sapete bene che, se anche avessi voluto, il credo cristiano me lo impedisce…ma, forse è stato quel bestemmiatore contro natura di Pico, oppure quel maledetto di Poliziano, che inveisce contro di me per scagionarsi>.
Lasciammo il convento per ritornare alla magione. L’indomani ci recammo nuovamente alla villa medicea di Careggi; in giardino incontrammo Marsilio Ficino, il traduttore in latino di tutte le opere platoniche e uomo stimato dal Magnifico.
Ci trattenemmo a lungo a parlare con lui, venendo a conoscenza di dettagli interessanti circa il banchetto di quella sera e riguardo i rapporti del Poliziano e di Pico della Mirandola con Lorenzo de’ Medici. In particolare, quest’ultimo, a detta di Ficino, in tempi recenti aveva avuto numerosi alterchi col signore di Firenze.
IV
PARTE QUARTA: Incontro con Pico della Mirandola
« […] Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.- […] Nell’uomo nascente il Padre ripose semi d’ogni specie e germi d’ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. […] se sensibili, sarà bruto, se razionali, diventerà anima celeste, se intellettuali, sarà angelo, e si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, […]. »
(Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate)
<È la verità ! Negli ultimi tempi ho avuto numerose e frequenti liti con Lorenzo> in questo modo, messer Pico rispose alla domanda del mio maestro,< ma sicuramente non avrei mai fatto del male all’ uomo che ritenevo alla stregua di un fratello>. < Posso chiedere la causa delle vostre discordie?> chiese Guido.< È una questione molto delicata, ne va della mia vita. Ve ne parlerò a patto che giuriate di mantenere la massima discrezione>. <Lo giuriamo !> esclamammo all’unisono. < Bene, da qualche tempo in città si è sparsa una diceria secondo cui io ho una concubina segreta; ebbene, questa voce non è vera, o, per meglio dire, non è del tutto vera. Infatti, lo ammetto davanti a voi e siete i primi a cui lo dico apertamente, ho un rapporto amoroso con l’umanista Girolamo Benivieni ; Lorenzo l’aveva compreso leggendo alcuni scritti, tra cui sonetti, che quello mi aveva dedicato. Inutile dire che il Magnifico non era per niente d’accordo. Il banchetto dell’altra sera fu un’occasione di riconciliazione e di questo me ne rallegro, poiché la morte lo accolto quando eravamo in pace fra di noi. < E dei suoi rapporti col segretario cosa mi dite ?> disse Guido. < I rapporti di Lorenzo con Angelo Poliziano sono sempre stati ottimi. Egli è un uomo stimato da tutti, me compreso. Forse è eccessivamente orgoglioso, superbo ed arrogante nei dibattiti tra studiosi. Ma è un grande intellettuale, oltreché un grande uomo. Inoltre non ricava nessun guadagno dalla morte del nostro signore. L’incontro stava volgendo al termine e io, nella impudenza dei vent’anni, gli chiesi se davvero era capace di ripetere i canti della Commedia al contrario, partendo dall’ultimo verso, come si raccontava.
Lo fece.
V
PARTE QUINTA: Lettera del Poliziano a Iacopo Antiquario. Resoconto degli ultimi istanti di vita di Lorenzo de’ Medici.
Ora, per onor del vero, riporto il testo di un’epistola scritta dal Poliziano a un conoscente. Tale epistola venne ricuperata da Guido, stimandola utile per le indagini che stavamo compiendo e, quando le nostre strade si separarono, rimase a me.
La lettera oramai è ingiallita e solo parte di essa è ancora leggibile.
…e qui il testo diventa illeggibile.
VI
PARTE SESTA: I funerali
« la quale [Firenze] sí come in vita sua, raccolto insieme ogni cosa, era stata felice, cosí doppo la morte sua cadde in tante calamità ed infortuni, che multiplicorono infinitamente el desiderio di lui e la riputazione sua. »
(Francesco Guicciardini, Storie Fiorentine, cap.IX)
Le esequie funebri si tennero presso il convento di San Marco, gremito dal popolo che veniva per rendere omaggio all’uomo che più di tutti diede lustro al nome di Firenze.
Lorenzo aveva disposto che il rito fosse privo di pompa e che il suo corpo fosse deposto nella Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo, la chiesa di famiglia. Guido ed io partecipammo al funerale, ma il nostro pensiero era completamente rivolto a scorgere l’assassino.
A quel punto era chiaro che avevamo fatto un buco nell’acqua: l’omicida non era uno dei partecipanti al banchetto, di conseguenza l’arsenico non era stato occultato tra gli alimenti. Dinanzi a noi si aprivano infinite strade e, per questo, sembrava quasi giunta l’ora di dichiarare il fallimento dell’indagine. Strutti da queste elucubrazioni, rincasammo. Proprio per allontanare il pensiero dell’ insuccesso, Guido mi chiese di prendere l’Eneide , la cui lettura lo avrebbe consolato. Nell’atto di prendere quel testo urtai accidentalmente contro un altro volume che si riversò a terra, sfaldandosi. Il mio maestrò si chinò per raccogliere i vari fogli e, a un tratto, il suo sguardò si fissò su uno di essi. Sentii che lesse: < Dà mi basia mille, deinde centum, dein mille altera, dein secunda centum…> una vampa attraversò i suoi occhi; esclamò:<Ho capito! Il nostro errore è stato quello di pensare che l’assassino fosse uno dei commensali, invece non è affatto così. Giulio ricordi quello che Piero ci disse riguardo a ciò che fecero quella sera dopo il banchetto?>. < Mi sembra che siano ritornati a Palazzo Medici, poi Lorenzo fece quello che faceva di solito: sbrigava degli uffici e vedeva delle donne> risposi. < Esatto ! E io, sciocco, non diedi peso a questo; ma è propria allora che Lorenzo è stato avvelenato, e sai da chi?> mi interrogò,< Non ne ho la più pallida idea, maestro !>. < Da una donna ! Leggendo il V carme catulliano, mi sono ricordato di aver sentito parlare di alcuni uomini che sono morti per aver baciato donne con arsenico sulle labbra, spesso prostitute. Non ci resta che scoprire chi sia quella donna, prepara i cavalli ! >.
VII
PARTE SETTIMA: L’epilogo della vicenda
Ardo d’amore, e conviemme cantare
per una dama che me strugge el cuore,
ch’ogni otta ch’i’ la sento ricordare,
el cor me brilla e par ch’egli esca fuore.
Ella non truova de bellezze pare,
cogli occhi gitta fiaccole d’amore;
i’ sono stato in città e ‘n castella
e mai ne vidi ignuna tanto bella.
(Lorenzo de’ Medici, dedicato a Lucrezia Donati)
<Ricordate il nome delle donne che frequentava vostro padre ?> domandò il mio precettore a Piero de’ Medici. <Mi chiedete un grande sforzo mnemonico, Guido, considerando che, da quando è morta mia madre, Lorenzo ha avuto in favore molte donne, la maggior parte meretrici>. <Lo immaginavo. Nell’ultimo periodo, non ce n’era nemmeno una in particolare ?> ribatté. Piero meditò a lungo, poi:< Pensandoci bene, all’incirca nell’ultimo mese, egli vedeva sovente una certa donna che si chiama…si chiama Beatrice Ardighelli>. <L’ha vista la sera prima della morte ?> incalzò il mio maestro.< Credo di sì… ne sono quasi certo>. < Dove posso trovarla?>, <Presso il lupanare del lungarno>. La trovammo lì, in un ambiente squallido. < Sappiamo che siete stata voi ad avvelenare Lorenzo de’ Medici. Vogliamo sapere chi sono i mandanti dell’omicidio> esordì Guido. <Non c’è nessun mandante, ho fatto tutto di mia sponte >rispose. Rimanemmo esterrefatti. < Solo per il piacere di uccidere Lorenzo il Magnifico ?> chiesi. < No, non per quello, ma per vendetta… Lorenzo de’ Medici era mio padre !> . La sorpresa aumentò.< Non guardatemi come una pazza, quello che ho detto corrisponde al vero. Mia madre, Lucrezia, figlia di Manno Donati e Caterina Bardi, era una gentildonna appartenente ad una famiglia nobile decaduta e l’ultima figlia della coppia. Sin dall’età di circa sedici anni fu amata da Lorenzo il Magnifico, anche se egli dovette poi sposare, per questioni di stato, la nobile romana Clarice Orsini. La abbandonò con me in grembo. Per questo, subito dopo, sposò il mio patrigno, Niccolò Ardighelli, il quale, non considerandomi mai davvero sua figlia, non mi lasciò alcuna sostanza. Per questo, mi trovo nelle condizioni di una meretrice. Quando Lorenzo mi avvicinò, intravidi la possibilità di riscatto e, nella mia follia, s’insinuò la speranza che mia accogliesse come una figlia. Così, una sera, gli rivelai la verità, mostrandogli il prezioso pugio che anni prima aveva regalato a mia madre. Anziché ricevermi come una figlia ritrovata, inveì contro di me, dicendomi che oramai non ero altro che una meretrice e mi costrinse a giacere con lui, pur sapendo di essere mio padre.
L’istinto mi avrebbe portato a freddarlo con lo stiletto che aveva donato a mia madre, però non ne ebbi il coraggio. Da allora iniziai ad escogitare un piano per vendicarmi e…sapete bene, com’è finita>. Mentre proferiva queste parole, rigirava tra le mani il pugio di cui ci aveva detto. I suoi occhi rilucevano, osservando la lama.< Non è uno splendido pugnale ?> disse. <Sì, è davvero molto ben conservato; ma, forse è il caso che lo diate a me > rispose Guido. <Era un’arma secondaria rispetto al gladius, ma gli imperatori romani la portavano come simbolo di vita e di morte >. Dicendo ciò, si trafisse, senza che noi riuscissimo a salvarla.
La vicenda rimase nascosta. Si preferì far credere che Lorenzo il Magnifico fosse morto a causa di un’ulcera, anziché per mano di una meretrice. Figlia su , per giunta.
La strada del mio maestro, poco dopo queste vicende, si separò dalla mia. Lui viaggiò per il mondo, perché -come sosteneva Sant’Agostino- “Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne conosce una pagina soltanto.” Io, invece, andai a Parigi, per studiare alla Sorbona, università in cui insegnò anche San Tommaso d’Aquino e luogo dove ho avuto modo di incontrare uomini straordinari.
Ora, il momento che ho atteso per anni, quando ero lì, sta per arrivare. Sto per ricongiungermi col mio maestro, Guido.
Qui, a Hierapolis. Hierapolis , finalmente !”.
Hierapolis Finalmente
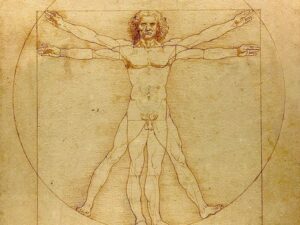
SCRITTO DA SIMONE ZANELLA
Lo immagino così l’inizio dell’evento, in un giorno qualsiasi su finire del Quattrocento, vento
gelido proveniente da Nord, occhi socchiusi, nel vano tentativo di proteggersi, e mani e braccia
congiunte in un abbraccio come unico riparo possibile, al momento, per un corpo troppo
esposto alla forza vitale degli elementi.
In quella posizione, dall’alto di un lembo di terra che, cadendo giù in verticale nel vuoto, andava
a infrangersi lungo la linea schiumosa e irregolare di un azzurro mare intenso, si ricordò di aver
sentito parlare una volta di un disegno dove, all’interno di un quadrato i cui vertici erano inscritti
all’interno di una circonferenza, era inserita una figura umana che, nella sua interezza, risultava
essere sovrapposta a se stessa. Si sentiva così, come la parte nascosta dell’uomo vitruviano,
solo un po’ più timido e introverso, quasi fosse il suo contrario o, per meglio dire, il suo rovescio.
Comincia così questa storia, o per meglio dire giunge al suo termine. E con essa, la curiosa
odissea di chi non tollera di accettare passivamente la sconfitta. Eppure, quel giovane, esile
soldato che avanzava rapido, con il respiro troncato dall’ansia e dalla fatica, spinto
dall’importanza di servire il proprio sovrano, non aveva mai concepito, sino ad allora, un siffatto
desiderio di fuga, che vedeva i suoi primordi nella profondità del suo animo. Quando Ludovico il
Moro chiamò in suo aiuto il re di Francia Carlo VIII di Valois, per rifuggire segretamente il
problema rappresentato dal matrimonio tra suo nipote Gain Galeazzo Maria e una nipote del re
di Napoli, Ferdinando, detto Ferrante, d’Aragona, una indescrivibile emozione prese a
serpeggiare nel petto di quel giovane bretone, addestrato alla guerra e nutrito di una grande
forza d’animo, ben moderata da una lungimirante visione del cristianesimo. Il cuore gli batteva
energicamente, la sua mente volava altrove e un implacabile movimento, quasi spasmodico,
scuoteva le sue giovani membra. E così si risolse a fiancheggiare re Carlo nella sua impresa,
senza tuttavia avere contezza di quanto si accingeva a compiere. Il punto era che egli, al pari di
Ludovico il Moro, stimava che l’impresa del sovrano si sarebbe limitata alla riconquista di
Napoli, per riportarla nelle mani degli Angiò, la corte che aveva sempre servita con umiltà e
devozione. Ignorava in toto la vera aspirazione di Carlo VIII: un re poliedrico, che bramava ogni
genere di conoscenza e, acquisitane una nuova, la scandagliava in ogni suo più remoto angolo,
al fine di trovarvi dell’utile. Ma la sua cultura sconfinata era punteggiata di quella follia che
appartiene ai detentori del potere, a cui si combinava una straordinaria forza di volontà. Sicché
costui, quando l’equilibrio dell’Italia intera vacillava dopo la morte di Lorenzo il Magnifico,
concepì i piani più grandi dietro alla rapida sottomissione di Napoli. Guardava a se stesso con
quella stessa autostima che ebbero Giovanna D’Arco, Cola di Rienzo, Girolamo Savonarola;
concepiva articolati progetti riguardo alla sua azione sul suolo italiano: e fu così che decise di
invadere il territorio italiano. Al suo seguito, l’esercito più organizzato e meglio strutturato: una
magnifica artiglieria e quindicimila uomini, tra agili cavalieri e veloci fanti; tra questi ultimi, vi era
anche quel giovane, che vi aderì con orgoglio, nonostante le difficoltà.
Il viaggio aveva il sapore degli episodi più affascinanti della storia dell’umanità. La traversata
delle Alpi richiamavano la valentia di Annibale e dei suoi uomini che, con un esercito
decisamente meno organizzato e strutturato meramente sulla forza e pertanto meno preparato
ad affrontare il tempo inclemente, era riuscito in ogni caso a valicare brillantemente l’impervia
catena montuosa. E, allo stesso modo, gli uomini di Carlo VIII avanzavano per i sentieri
scoscesi dei monti. Il giovane bretone procedeva con passo deciso e veloce, malgrado il suo
esile corpo, giacché il fine che lo conduceva per quelle strade gli instillava l’incoercibile
desiderio di continuare nel viaggio e di non curarsi della fatica. A ciò si univa anche la
prospettiva della ricompensa, ché la prima sosta della spedizione era la città di Milano, in cui
Ludovico il Moro attendeva di elargire favori e gratitudine al sovrano. Quest’ultimo, di fatto, non
aveva più la necessità di premere affinché Carlo VIII proseguisse nella sua opera, in quanto
Gian Galeazzo Maria era da poco morto – circostanze disgraziate o fredda premeditazione? –;
tuttavia non la scoraggiò e l’armata francese proseguì verso Firenze. Fu solo giunti nella città
dei Medici che il giovane fante cominciò ad avvertire l’ingiustizia delle loro azioni. Attraversando
via Tornabuoni, una volta siglato l’accordo con Piero de’ Medici, che stabiliva il passaggio di
Pisa nelle mani dei Francesi, egli, per quanto giovane, avvertì con dispiacere e sconsolazione
l’atteggiamento passivo, sottomesso di quella signoria, che eccelleva per cultura e sapienza
politica, ma che in quel momento, almeno come sembrava, aveva messo da parte queste sue
virtù. Egli si accorse del vento di cambiamento che attraversava la città. Era pur vero che quello
era il suo primo ingresso; senonché, l’andirivieni affannato di gente che gridava denunzie contro
la corruzione morale e minacciava roghi di «vanità» erano il segno dell’inizio di una radicale
modifica. Ma era la paura di tutto ciò che gravava i fiorentini a tal punto da annichilirli di fronte
alle pretese di un megalomane sovrano? Quale che fosse la ragione, essa era sconosciuta a
quel ragazzo, tuttavia poteva comprendere appieno l’errore che Carlo VIII commetteva,
volgendo a proprio favore una simile situazione. D’altronde, non riusciva a disprezzarlo per il
forte legame che entrambi avevano con il cristianesimo. Negli ultimi periodi di quel viaggio,
oltretutto, una voce aveva preso a circolare, con una certa discrezione, tra il grande esercito:
secondo l’opinione di molti, Carlo VIII era sempre più persuaso di essere predestinato a
ricostituire l’ordine della Chiesa, vale a dire, rimuovere il frutto marcio della corruzione che da
lungo tempo aveva favorita l’estensione della putredine in tutta la vastità dei fedeli della Chiesa
Latina. C’era anche chi sosteneva che il re venisse stimolato a ciò da voci di santi, come
Giovanna D’Arco. E costui, effettivamente, aveva presa la via di Roma. Lì, in quel momento, il
papato di Alessandro VI Borgia inacidiva gli animi di chi percepiva la bassezza a cui la Chiesa si
era abbandonata: il papa era, infatti, nipote di uno dei più importanti signori italiani e ciò
significava che la sua candidatura a capo della Cristianità non era casuale, ma era finalizzata al
rafforzamento della signoria dei Borgia e del progetto di monarchia papale che emergeva nel
Lazio.
Da fervente cristiano, il giovane fante bretone non aveva potuto che accogliere euforicamente la
disposizione d’animo di quel grande re, che aveva scelto di entrare direttamente nel campo di
battaglia e di affrontare un viaggio lungo, difficile ed esposto a una innumerevole quantità di
minacce. Ma avrebbe mai potuto immaginare che i propositi di rivoluzione di Carlo VIII si
sarebbero ridotti a un cenno affermativo del capo dinanzi all’autorità di Alessandro VI, che
proponeva chissà quale losco piano? Tale fu la delusione, che egli aveva cominciato a nutrire
un desiderio irrealizzabile, la diserzione, la fuga in qualche posto sperduto. Nelle sue terre natie,
i romanzi cavallereschi che i trovieri avevano composto in tanti anni di tradizione letteraria
riportavano spesso le descrizioni delle terre asiatiche e di un luogo in particolare, un florido
borgo disabitato sulla costa di un mare meraviglioso. La conferma della sua esistenza era data
dalle cronache dei primi esploratori del Vicino Oriente, che registravano, nelle loro pagine
prolisse e scarne a un tempo, il colore di quel mare. Ed esso prendeva plasticamente la sua
forma nella mente di quel giovane soldato: udiva lo scroscio delle onde sulla costa frastagliata,
sentiva il profumo del mare, un mare così diverso e sconosciuto, così blu e limpido…
Guardava il mare anche nell’estate del 1495, quando, con lui, vi erano ancora pochi soldati
francesi. Egli ammirava, dalla straordinaria Napoli, le onde che lentamente si appropinquavano
ai sassi delle spiagge e vi si scontravano. Cosa mai era accaduto fino ad allora? Carlo VIII
aveva perso. La sua forza, la sua tenacia, la sua cultura intrisa di mirabile astuzia aveva
prodotto un risultato fallimentare. Se n’era quindi tornato in Francia con buona parte
dell’esercito, dopo aver scampata per poco la sconfitta a Fornovo. Pochi fanti e pochi cavalieri
erano invece rimasti a Napoli, ove tentarono con ogni mezzo di mantenere saldo il possesso
della città. Senonché la delusione, la stanchezza, lo sconforto avevano fiaccato le truppe e,
all’arrivo degli Aragonesi, non seppero resistere. E a quel punto cosa rimaneva? Di tanto in
tanto, il giovane bretone si abbandonava alla vista del mare e la sua mente si perdeva tra le
onde, lasciando così che la drammatica vicenda si allontanasse del pensiero. Non dimenticava,
però, quello che era stato il suo ruolo fino ad allora ed era, pertanto, ancora disposto a offrire i
suoi servigi a un signore; non già a un regnante che mirava alla sottomissione totale dei suoi
sudditi, quale era quello aragonese, bensì a un signore che detenesse il potere solo
formalmente, nel cui stato i cittadini godessero, per quanto fosse possibile, di pari dignità e
vivessero tra di loro rispettandosi e aiutandosi reciprocamente. Egli vedeva incarnarsi questa
sua idea di stato nelle repubbliche marinare, le cui navi mercantili, ogni giorno, approdavano e
salpavano da Napoli. Si trattava, in verità, delle sole navi genovesi e veneziane, giacché Pisa e
Amalfi avevano oramai perso il loro predominio. Pisa abbandonò le proprie rotte commerciali sul
mar Tirreno quando l’alleanza con Genova cominciò a incrinarsi nel 1119, ai tempi in cui veniva
eletto papa Callisto II, vale a dire colui che, nel 1124, con l’imperatore Enrico V, pose fine alla
lotta per le investiture con il concordato di Worms: a quei tempi, dunque, i commerci erano
ancora un’attività che, per quanto potesse risultare redditizia per l’impero stesso, rimaneva
circoscritta alle città che la praticavano. Tanto più che i poteri universali dovevano sciogliere il
complesso nodo delle loro relazioni. Ciò significa che la guerra che Genova intraprese contro
Pisa passò pressoché inosservata per molto tempo, fino a quando la Battaglia della Meloria, del
1284, decretò la fine della potenza commerciale pisana. Quanto ad Amalfi, essa era già stata
messa da tempo fuori gioco da Pisa, che si impossessò anche di tutte le sue conquiste culturali
– ché gli amalfitani furono i primi a conoscere l’uso della bussola e a redigere un codice
commerciale marittimo, le tavole amalfitane. Rimanevano, quindi, solo Genova e Venezia sulla
scena dei commerci via mare. E la loro relazione fu prettamente costituita da scontri: dopo che
Genova ebbe sottratto il dominio costantinopolitano ai lagunari, costoro accettarono di risolvere
il contenzioso nel 1299, con un trattato che sanciva l’egemonia sull’Adriatico di Venezia e quella
sul Tirreno di Genova. Ma su chi delle due avesse dovuto avere Costantinopoli, non si
accordarono mai e quando, dopo un secolo, nel 1378, si scontrarono nuovamente, Venezia
ebbe la meglio e guadagnò il controllo del Mediterraneo orientale.
Così, tutte le imbarcazioni veneziane che sostavano a Napoli arrivavano fino in Asia minore.
L’Asia: un luogo di cui quel giovane soldato dei Francesi aveva sentito parlare solo nei cicli di
storie dei trovieri, in cui qualche cavaliere si avventurava per salvare donne indifese o
recuperare oggetti mistici legati a Cristo, oppure in quelle cronache che era solito leggere con
tanto interesse. Non l’aveva mai immaginata di certo come un luogo florido e ospitale, ma aveva
iniziato a cambiare idea constatando di persona quali ricchezze, dalle spezie ai tessuti più
pregiati, quei mercanti portavano con sé. Era ormai affatto pervaso dalla curiosità: quasi
meccanicamente, si recò presso un gruppo di mercanti veneziani, giurando di voler lavorare per
il benessere della Serenissima sino alla fine dei suoi giorni. Quei commercianti, in un primo
momento stupiti e divertiti dall’audacia di quel giovinetto, lo schernirono con battute salaci;
senonché, dopo aver preso atto della sua determinazione, scelsero di metterlo alla prova e di
verificare se egli fosse stato realmente disposto ad apprendere la nuova arte. Dalla Francia al
Mediterraneo: il giovane soldato non aveva ancora terminato quell’avventuroso viaggio, intriso
di coraggio e delusioni, scoperte e timori. Vide le calde, turchesi, quiete acque del Mediterraneo,
visitò le isole di quella Grecia di cui aveva tanto sentito parlare nel florido ambiente culturale
napoletano con ossequio e amore, assistette alle accurate tecniche commerciali veneziane.
Lo stupore lo pervase un mattino, sul far del giorno, in una fredda alba di fine 1495. La barca si
stava inoltrando tra delle anse formate dagli scogli a picco sul mare. In lontananza si
intravedeva l’approdo e, di fianco alla barca, si stagliava un grande promontorio frastagliato,
sulla cima del quale era appena visibile una pallida e scarsissima vegetazione, abbattuta dal
freddo, e delle alte colonne dal fusto liscio, con dei capitelli riccamente decorati dalla scultura di
foglie d’acanto. Erano bianche, come il cielo che, poco a poco, si tingeva dello stesso colore del
mare. Il giovane fu commosso da quanto vedeva, dal creato di quel Dio a cui aveva chiesto
pietà e misericordia durante tutto quel tempo: comprese l’amore nella sua espressione più alta
osservando quanto l’opera divina potesse essere perfetta. Dopo essere sbarcato, raggiunse
con foga il posto che aveva appena individuato, tra il vento che scompigliava i suoi abiti e la
stanchezza che si era impossessata delle sue membra. C’era qualcosa di più in
quell’inarrestabile brama di raggiungere il posto sulla cima della scogliera: egli era certo di
averne già avuta notizia. «Hierapolis!» tuonò a un certo punto nella sua mente. «Hierapolis»,
vale a dire, la «città santa». Sì, il luogo che le cronache dei viaggiatori avevano descritto così
bene da lasciare che l’immaginazione lo plasmasse nella sua mente. E invero lo aveva sempre
immaginato così. Il giovane soldato, incurante del tempo che scorreva e delle sue attività
mercantili, si appoggiò a una di quelle colonne che aveva viste, appartenenti a quanto rimaneva
di un grande tempio pagano. Sentiva che nulla lo avrebbe più spinto ad andarsene. Da lì,
contemplò il mare e gli scogli bianchi, lasciando che il forte vento, per quanto freddo, lo
sferzasse, lo attraversasse. Il benessere che gli infondeva la «città santa» era assolutamente
indescrivibile: gli pareva di aver aspettato tutta la vita quel momento.
Hierapolis, finalmente.

