TRA LEGGE PROVVEDIMENTO E RISERVA DI PROCEDIMENTO .

Scorti da lontano una quarantina di antichi mulini, le cui pale roteavano incessantemente al vento in guisa di braccia vigorose ed aitanti di giganti, il prode cavaliere Don Chisciotte Della Mancia – in preda al proprio bellicoso furore – esclamò: “Vedi là, amico Sancio, come si vengono manifestando trenta, o poco più, smisurati giganti? Io penso di azzuffarmi con essi, cominciare ad arricchirmi con le loro spoglie uccidendoli”. Al che il suo umile scudiere Sancio Panza gli chiese, scettico e sconsolato: “Dove sono i giganti?”. E l’intrepido guerriero così rispose: “Quelli che vedi laggiù, con quelle braccia così lunghe che taluno d’essi le ha quasi lunghe due leghe”.
L’audace cavaliere si scagliava allora furente alla carica contro di essi, in fiera e diseguale tenzone, protraendo nel vento la propria lancia acuminata e gridando follemente “Non fuggite, codarde e vili creature, chè uno solo è il cavaliere che viene con voi a battaglia … potreste agitare più braccia del gigante Briareo, ché me l’avete pur da pagare”: e non sapeva – o stolto! – che quelli che andava aggredendo altro non erano che dei macchinari destinati alla molatura del grano. Scontratosi rovinosamente contro una delle pale ed impigliatosi nel suo meccanismo rotante, il nobile guerriero finiva gambe all’aria, insieme al suo splendente usbergo ed alla sua superba cavalcatura.
Sancio, che aveva indarno tentato di dissuaderlo dalla temeraria impresa, non poteva che accorrere, aiutandolo a rimettersi in piedi ed a raccogliere i propri effetti personali sparpagliati qua e là. Mentre il fidato amico lo soccorreva, il Chisciotte così si consolava: “Taci, amico Sancio; le cose della guerra sono più delle altre soggette a continuo cambiamento; massimamente perché stimo, e così senza dubbio dev’essere, che il savio Frestone, il quale mi svaligiò la stanza e portò via i libri, abbia mutati questi giganti in mulini per togliermi la gloria di restar vincitore”.
Il nobile cavaliere, sconsolato dopo essersi accorto del proprio grossolano errore, si trova costretto a constatare una realtà molto diversa da quella apparente: quelli che gli parevano dei temibili giganti altri non erano, in realtà, che degli inoffensivi mulini a vento e la sua eroica cavalcata era stata, dunque, ingloriosamente interrotta da una pesante pala eolica.
Il senso di straniamento e di disillusione patito dal nobilissimo uomo d’arme è, in realtà, lo stesso che hanno suscitato presso la giurisprudenza costituzionale le tanto politicamente ed economicamente sensibili leggi provvedimento.
Definiamo leggi provvedimento gli atti che – seppur approvati con il comune procedimento legislativo ed aventi natura giuridica di legge – sono in concreto destinati alla disciplina di un numerus ristretto e ben determinato di fattispecie di fatto: non sono, dunque, fonti del diritto generali ed astratte, ma atti decisionali concreti, indirizzati contro soggetti determinati o determinabili e destinati all’applicazione entro uno spatium modestissimo di vicende e circostanze pratiche.
In altre parole, le leggi provvedimento possono essere definite come atti formalmente legislativi, ma sostanzialmente amministrativi e provvedimentali: ma quali le conseguenze di chiamare falsis nominibus legge l’atto nel quale si intende in realtà infondere il contenuto concreto di un provvedimento amministrativo? E perché ricorrere al mezzo, apparentemente più solenne della legge, anziché a quello più banale, semplice e multiforme del provvedimento? I vantaggi, all’atto pratico, sono in realtà molti, e di non poco conto.
Primitus, lo strumento legislativo è una fonte del diritto i cui mezzi di sindacato sono ben più limitati rispetto ai provvedimenti emanati dall’amministrazione: sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, la legge può, infatti, essere censurata esclusivamente dalla Corte Costituzionale, nella sua funzione di giudice delle Leggi.
Inoltre, nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sono precluse le censure sulla motivazione della provvedimento e sul rapporto tra amministrazione ed amministrato nel suo complesso delinearsi: immotivata ed espressione di una volontè generale di natura squisitamente politica, la legge non potrà veder aggrediti i propri vizi motivazionali, ma solo le proprie lacune formali. Dunque, al lordo della censura di eventuali vizi del procedimento legislativo o di antinomie normative tra la legge e le fonti del diritto ad essa subordinate, ben poche saranno le armi a disposizione della Consulta: e financo il giudizio di ragionevolezza in astratto, come esercitato dalla Corte Costituzionale – rimane meno pervasivo del sindacato proprio del giudice amministrativo, imperniato intorno alla figura dell’eccesso di potere ed alle sue svariate figure sintomatiche, oltre che fondato sul costante accesso a motivazioni ed atti procedimentali preparatori nel contesto di un processo dotato di istruttoria e contraddittorio tra le parti.
Infine, del tutto carenti saranno le garanzie procedimentali assicurate dalla legge n. 241/1990 e dalla legislazione speciale: dalla partecipazione al procedimento amministrativo, al diritto al contraddittorio pre-provvedimentale tramite il deposito di memorie e preavviso di rigetto, all’accesso agli atti ed alle motivazioni, et cetera. Eppure, come autorevolmente rilevato dal GIANNINI, proprio il procedimento amministrativo è la sede d’elezione del bilanciamento tra gli interessi e della partecipazione dei soggetti interessati: verbis nostris, il procedimento è la sede di elezione del dialogo reciproco tra amministrazione pubblica ed amministrato, oltre che del bilanciamento tra opposti interessi, pubblici o privati che siano.
Negare il procedimento, dietro al facile quanto falso velo di Maya della democraticità dello strumento legale, significa negare proditoriamente tali garanzie procedimentali agli amministrati.
E, dunque, il destinatario della legge provvedimento si trova in mano una spada dilaniata in due parti e ben poco inservibile: proprio come il nostro , che fu costretto a procurarsi un ramo d’albero per rimediare alla propria inopia dopo aver distrutto il proprio equipaggiamento bellico nella folle tenzone contro il mulino.
Ferma la generale legittimità – riconosciuta dalla stessa Consulta – del ricorso alla Legge provvedimento da parte di Stato e Regioni, vi è un caso nel quale il ricorso a questo strumento viene censurato: la legge provvedimento regionale disposta in deroga alla normativa nazionale introducente un procedimento amministrativo ad hoc. Ciò in quanto, avendo il Legislatore nazionale previsto a priori l’impiego di moduli procedimentali specifici finalizzati al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi in questione, alle Regioni non è consentito ricorrere ad itinera procedimentali alternativi.
In effetti, già nel 2012 la Corte Costituzionale aveva avuto modo di prendere la parola in proposito, con riferimento alla LR sarda 29.05.2007, n. 2, la quale disponeva intorno ad altrettanto insidiosi – ancorché meno celebri – mulini a vento.
Ea tempestate, il Collegio aveva evidenziato che «Il legislatore statale […] attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto princìpi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione».
Già, dunque, la Corte faceva emergere come la puntuale sequela delle norme procedimentali, in ossequio alle “competenze statali, regionali e provinciali” fosse l’unico mezzo tramite il quale gli Enti pubblici coinvolti avrebbero potuto perseguire “una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”: una legalità procedimentale intesa, dunque, quale strumento di leale collaborazione e dialogo tra Amministrazioni pubbliche concorrentemente competenti.
In una successiva e celeberrima vertenza la Consulta si è spinta ad evidenziare il valore garantistico del principio di legalità procedimentale, anche quale mezzo di garanzia degli interessati privati, con sent. n. 69/2018.
La pronuncia ebbe origine dalla LR veneta 30.12.2016, n. 30.
Materia del contendere era stata la scelta del Legislatore Regionale Veneto di introdurre ex lege un apparato di distanze legali tra i manufatti ospitanti gli impianti di produzione elettrica a biomasse e gli abitati forfettariamente predeterminate in misura fissa: contravvenendo alla legge “quadro” nazionale, la quale prevedeva invece il ricorso a procedimenti autorizzativi ad hoc, segnatamente finalizzati alla determinazione dei più opportuni distanziamenti tramite l’intervento attivo degli amministrati e la valutazione delle caratteristiche proprie di ciascun contesto geografico.
In proposito, il Collegio rilevava che “I regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile (…) rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale”. Ciò in quanto è in tale sede soltanto che si può aristotelicamente individuare il miglior bilanciamento con la polimorfa pluralità di interessi contrapposti alla pubblica necessità di approvigionamento energetico e diffusione sul territorio degli impianti: tra questi indica la Corte a titolo esemplificativo “esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio”.
La presa di posizione della Consulta è, dunque, perentoria ed esplicita: il Collegio afferma, infatti, che “la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, (…) attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (…)”. Pertanto, “è nella sede procedimentale […] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela”: ciò, in quanto è “la struttura del procedimento amministrativo [che] rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza”.
In aggiunta a ciò, la partecipazione istruttoria dei cittadini interessati ed il loro supporto nella ricognizione degli interessi coinvolti dal provvedimento perfezionando avrebbero, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi, un valore imprescindibile: sicché risulterebbe solo “In tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost”. In effetti, l’apporto dei cittadini alle procedure decisionali può fornire già in sede istruttoria preziosi ammonimenti intorno agli interessi privati i quali andrebbero – altrimenti – irreparabilmente dispersi: somministrando alla PA la propria scienza intorno ai fatti oggetto del deliberare e svolgendo una previa ricognizione delle proprie ragioni, gli amministrati consentono un più razionale, agevole e satisfattivo esercizio della funzione pubblica, oltre a minimizzare il rischio di eventuali liti future. Sicché, lo strumento del procedimento viene al contempo a soddisfare le esigenze di legalità procedimentale e sostanziale: afferma, infatti, la Consulta che “In definitiva viene in tal modo garantito il rispetto del principio di legalità − anch’esso desumibile dall’art. 97 Cost. − in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione. Difatti, a chiusura del sistema, vi è la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale”.
Riverso a terra si trova, dunque, un cavaliere che si duole della recente caduta, resosi conto del proprio errore nel confondere l’identità del proprio avversario: allo stesso modo di un privato che – trovandosi interessato da una legge provvedimento – non riesca ad intenderne l’esatta qualifica.
La legge provvedimento è, in effetti, un vero e proprio Giano Bifronte dotato di una natura giuridica ancipite, contro la quale l’ordinamento costituzionale non prevede però alcun baluardo a difesa del cittadino: eccezion fatta per quanto riguarda il diritto regionale, dove il ricorso alla legge provvedimento deve ritenersi escluso allorché il legislatore statale abbia dettato delle norme procedimentali destinate a disciplinare gli itinera procedimentali amministrativi, rimanendo in caso contrario legittimo.
Dall’analisi della prefata giurisprudenza si possono trarre numerose conclusioni: ribadito in via sistematica l’obbligo gravante sulle Regioni ordinarie di conformarsi ai principi generali dettati dalla legge quadro dello Stato in relazione alle materie di cui al co. 3 dell’art. 117 cost. (e riconosciuto come tali principi siano applicabili anche alle Regioni autonome quali la Sardegna nella parte in cui esprimano principi giuridici di matrice eurounionale) la Corte ha avuto modo di evidenziare il cruciale rilievo delle norme procedimentali nel ripartire le competenze amministrative degli Enti, nel garantire il rispetto dei diritti partecipativi degli interessati e nel favorire un ottimale bilanciamento tra diritti ed interessi pubblicamente e privatamente rilevanti, censurando la tendenza delle Regioni a coniare ex auctoritate leggi provvedimento che, nel nome dell’efficienza, incrinavano l’apparato di garanzie insito nel procedimento amministrativo.
Le citazioni iniziali sono state estrapolate passim da: Michele Cervantes, Le avventure di Don Chisciotte della Mancia e di Sancio Panza suo scudiere. Romanzo. I e II Parte riu
nite, Edizioni Aurora, Milano, 1934.
UN’OPERA ANTROPOCENTRICA

Un’opera anti-antropocentrica.
Testo di Matteo Mulè.
Mi è capitato di recente, dopo aver concluso un esame di letteratura italiana contemporanea, di
imbattermi in un’opera che viene spesso citata e ripresa, ma della quale non ebbi mai modo o
forse tempo di aprirla e di darle una lettura approfondita. Parlo delle Operette morali di Giacomo
Leopardi, uno dei pilastri della cultura italiana, conosciuto, almeno nelle antologie scolastiche,
più come poeta che come prosatore. È stato grazie a Italo Calvino, il quale ha rilasciato nel
corso di diverse interviste e nella prefazione di alcune sue opere una notevole quantità di
encomi, dove definiva Leopardi uno dei più grandi prosatori italiani. Una volta terminata la
lettura delle Operette Morali, ho avuto la possibilità di comprendere la grandissima influenza di
Leopardi sui romanzi del secondo Novecento, in particolar modo sulla scrittura di figure come
Levi e Calvino, laddove la finzione narrativa svela una realtà tetra e di difficile interpretazione.
L’opera si caratterizza per la sua eterogeneità dei temi trattati e dei diversi stili utilizzati nella
narrazione, anche se a dominare è il genere del dialogo tra due soggetti, al termine dei quali
non vi è quasi mai una conclusione chiara e definitiva, che stabilisca una verità, ma al contrario
una non-conclusione, che crea un’atmosfera di sospensione e di indeterminatezza. Questa
ricerca di una verità che possa portare beneficio agli uomini è già presente all’interno della
prima operetta: La storia del genere umano. L’uomo viene visto come un essere, a differenza
delle altre creature della Terra, insaziabile dei doni che gli vengono offerti dagli Dei e dallo
stesso pianeta. La noia è un elemento che lo caratterizza e lo rende avaro di conoscenza, di
andare sempre oltre a ciò che viene dato e di superare costantemente i limiti imposti. In questo
modo, già all’interno della prima operetta, Leopardi cerca di offrirci uno spunto di riflessione,
una domanda: da che cosa è dovuta l’infelicità dell’uomo che non sembra colpire le altre
creature? Probabilmente dall’ossessiva ricerca della Verità.
La Verità, ovvero il dono (o punizione) che Giove regala agli uomini per aiutarli a contrastare il tedio e l’infelicità, è vista da
Leopardi come una sorta di maledizione. <<Perocché laddove agli immortali ella dimostrava la
loro beatitudine, discoprirebbe agli uomini interamente e proporrebbe ai medesimi del continuo
dinanzi agli occhi la loro infelicità>> .
Avere maggiore consapevolezza della realtà e di noi stessi,
da Leopardi viene visto come un male, perché in questo modo ci renderemo conto della triste
condizione di uomini, incapaci di dominare una realtà in continuo mutamento, destinati a rincorrere dei piaceri caduchi, a confrontarci con una Natura indifferente alle questioni umane, pronta sempre a colpire con la sua forza. L’autore sembra quasi voler denigrare la funzione
salvifica della conoscenza, definendola una piaga per l’uomo, che lo porta solamente a contatto
con gli aspetti più oscuri e infelici della propria sorte. Per questo motivo nel Dialogo della Natura
e di un’Anima, quando Natura chiede all’anima se è disposta a reincarnarsi in un umano dotato
di somma conoscenza e di grande abilità (allude probabilmente alla figura del filosofo), che avrà
grandissima gloria tra gli uomini, soprattutto dopo la sua morte, l’anima risponde: << Dunque alluogami, se tu m’ami, nel più imperfetto: o se questo non puoi, spogliata delle funeste doti che
mi nobilitano, fammi conforme al più stupido e insensato spirito umano che tu producessi in alcun tempo>>.
L’aumento di conoscenza, per lo scrittore di Recanati, comporta inevitabilmente un accrescimento dell’infelicità dell’uomo. Il secolo XIX con le rivoluzioni industriali e con un
aumento dell’importanza del pensiero scientifico e razionale, eredità dell’illuminismo, può aver
portato ad un miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo, ma allo stesso tempo lo ha
condannato ad una vita sempre meno attiva e più dedita al pensiero, con conseguente
allontanamento dalla Natura. Per questo nel Dialogo di Plotino e di Porfirio si invidia la
condizione dei selvaggi, che vivono a stretto contatto con la natura e sono costretti a dedicare la
loro vita esclusivamente alla raccolta del cibo per poter sopravvivere, eliminando l’attività
intellettuale con la quale si può sviluppare questo tedio nei confronti dell’esistenza, che porta lo
stesso Porfirio a pensare al suicidio come una liberazione. La necessità di vivere una vita breve
e intensa anima diversi dialoghi all’interno dell’opera leopardiana, come ad esempio il Dialogo di un fisico e di un metafisico. Il fisico, che si può identificare con la figura del medico, sottolinea
come le sue scoperte possano portare ad un allungamento della vita dell’uomo e quindi ad un
suo miglioramento, mentre il metafisico, ovvero il filosofo, sostiene, al contrario, che è preferibile
vivere una vita breve e intensa, poiché essendo i dispiaceri sempre superiori in numero e
intensità ai piaceri, allora è meglio cercare di ridurli il più possibile. Il metafisico invidia la
condizione degli antichi che solevano morire presto, dato che vivevano una vita più pericolosa,
ma allo stesso ricca di emozioni e di esperienza, che non davano spazio alla noia, tanto temuta da Leopardi.
Le Operette morali si possono definire a tal proposito, riprendendo il titolo, un’opera anti-antropocentrica, perché mettono in discussione la centralità dell’uomo e le sue facoltà cognitive,
che lo illudono di poter determinare e dominare una realtà così sfuggevole. Leopardi, riflettendo
sulla condizione dell’intellettuale borghese, sembra anticipare il dominio della tecnica che si
svilupperà nel secondo Novecento, ove gli uomini, allontanandosi sempre di più della natura,
avranno una vita più agiata e longeva, ma allo stesso tempo priva di quelle emozioni intense
che ne arricchiscono l’esistenza, scandita, ormai, dai ritmi della fabbrica e del sistema.
Rileggere oggi l’opera di Leopardi, seppur distante a livello cronologico, può offrirci diversi
spunti di riflessione per rivalutare la nostra condizione esistenziale, con la consapevolezza del
fatto che questo viaggio verso la nostra interiorità, possa portare ad un accrescimento
dell’infelicità, ma allo stesso tempo ci può far aprire gli occhi dinnanzi alla mancanza di senso
che, a volte, avvertiamo.
Note:
1) Giacomo Leopardi, Operette morali, Feltrinelli, Milano, 2021.
2) Si fa riferimento a Primo Levi delle Storie naturali (1966) e del Sistema periodico (1975).
3) Tutta la produzione di Calvino è legata sempre da atmosfere fantastiche che analizzano la
nostra realtà contemporanea, penso, ad esempio, al Visconte dimezzato (1952), Il barone
rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959).
4) Giacomo Leopardi, Operette morali, cit., p. 67.
5) Ivi, p. 91
TESORI NASCOSTI
LA CIVILTÀ DELLA BIBLIOTECA
Scritto di Francesco Scarangella.
Chi scrive in Polis Futura cerca, per quanto gli sia possibile, di divulgare le proprie opinioni in forma originale ed accattivante: così da evitare, per quanto possibile, di addentrarsi tra verbosi tecnicisimi e inani virtuosismi, ma di suscitare la massima curiosità nel lettore.
In quanto membro di un’Associazione dotata di siffatte caratteristiche, non posso esimermi dallo spendere qualche parola intorno ai fatti che nelle ultime settimane hanno profondamente sconvolto – direi quasi sconquassato dalle fondamenta – l’antico, ma fragile edificio della vita culturale italiana.
Mi riferisco alle recenti alluvioni che, insistendo per parecchi giorni nelle pianure del Ravennate, hanno devastato molti tesori del locale patrimonio librario: oltre a trascinare, ahimè, con i propri flutti lutulenti molte vite.
Tra biblioteche, musei, pinacoteche, archivi e depositi, moltissimi sono i tesori che hanno dovuto pagare un conto salato alla gravissima inclemenza del meteo: la sola Biblioteca del Seminario vescovile di Forlì ha visto la distruzione di più di 1000 stampe tra Cinquecentine e Seicentine, oltre a 27 incunaboli.
Fare cultura, come ben si sa, risulta spesso ardua ed ingrata impresa. Conservarla nel tempo lo è in misura ancor maggiore. Eppure, l’uomo ha sempre cercato, nel lungo diffondersi della sua storia, di raccogliere enormi biblioteche capaci di mantenere traccia.
Ogni biblioteca è segno inconfondibile di civiltà, quasi che non possa esistere civiltà alcuna senza biblioteca: ubi societas, ibi bybliotheca, verrebbe quasi da concludere. E, del resto, comprendiamo di essere di fronte ad una civiltà sviluppata, proprio allorchè qualche biblioteca questa ci abbia lasciato: cosicché il libro, quasi come la voce di un popolo a noi cronologicamente precedente, è ciò che ci consente di riconoscerlo e di capirlo.
Cosicché una società senza libro è, per noi oggi, una società muta, una società priva della parola: una società che si conosce attraverso le parole di altri.
Una società quasi incapace di intendere e di volere, che abbisogna di un tutore per poter raccontare la propria storia: tra i tanti, i Celti, i Germani, i Britanni, i Cartaginesi e molti popoli orientali, che conosciamo prevalentemente attraverso il prisma delle parole altrui.
Ogni biblioteca è, per un motivo o per l’altro, destinata a perire: lo testimonia la storia della Biblioteca di Alessandria, sorta per opera di Tolomeo Filadelfo con l’intento ambizioso e, forse, tracotante di ergersi a vero e proprio scrigno di tutta la cultura greca arcaica, classica ed ellenistica. Questa, infatti, fu notoriamente avvolta dalle fiamme – non è certo né quando, né da chi, né perché – con la conseguente, irreparabile distruzione del suo immenso patrimonio.
Eppure, non si può certo nascondere che ogni nuova biblioteca di Alessandria, seppure costruita con la speranza di custodire ogni manifestazione dell’ingegno umano e durare in eterno, è destinata alla distruzione. Come, del resto, destinata alla distruzione è in ultima analisi ogni opera dell’uomo.
La stampa, prima, e la digitalizzazione, poi, hanno certo contribuito ad assicurare la conservazione di questi tesori, ma da sole non possono certo renderli totalmente invulnerabili. E le vicende narrate lo dimostrano.
- Ad avviso dello scrivente, queste constatazioni non dovrebbero indurre lo sconsolato lettore ad astenersi dall’attiva ricerca della cultura, disperando della perpetuità di essa: egli dovrebbe, semplicemente, rendersi consapevole del fatto che neppure la più ampia, ben costruita e resistente delle biblioteche è eterna.

FILOSOFIA

NICHILISMO O “OMNILISMO”? Manca il fine, manca la risposta al “perché”
Di Elena Soppelsa
Cos’è il nichilismo e perché parlarne significa smascherare uno dei più grandi disagi del nostro tempo?
Friedrich Nietzsche (1844-1900) fu probabilmente il pensatore che più di ogni altro si occupò di dare
voce al fenomeno del nichilismo, che si rese prepotentemente evidente proprio a partire dalla sua epoca – definita anche “disincantata” – quando tutti i valori tradizionali cominciarono a vacillare in seguito al susseguirsi di eventi storici che cambiarono la mentalità occidentale dell’umano.
Nietzsche definì il nichilismo con una descrizione tanto semplice quanto incisiva: “manca il fine,
manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano”
1.Il termine in questione infatti deriva dal latino “nihil” ovvero “nulla”, indicando proprio come la condizione dell’uomo annichilito sia quella di un vagare nel bel mezzo del nulla, senza obiettivi né valori concreti a cui appigliarsi: il nichilismo è una sensazione di “spaesamento”, di barcollamento nel buio.
C’è da dire inoltre che il filosofo tedesco non si limitò a descrivere / circoscrivere il nichilismo come
fenomeno legato meramente all’epoca in cui viveva, ma ne reperì la causa molti secoli prima, in particolare nella rivoluzione filosofica apportata da Socrate (tra il V e il IV sec. a.C)
2. Il filosofo chiama “dionisiaca” la fase in cui l’uomo viveva privo di nichilismo, assecondando quella
che era la sua vera natura, manifestando la sua “volontà di potenza” senza filtri né barriere.
A partire dalla comparsa di Socrate ha inizio, secondo il filosofo tedesco, la fase “apollinea”, ovvero una chiusura dell’umano su di sé, che lo ha portato a nascondere il suo animo dionisiaco per sottostare alle norme di comportamento – ipoteticamente virtuose – imposte da altri.
La fase di spaesamento dell’umano avviene dunque nel momento in cui l’individuo non si sente più libero di accettare e manifestare la parte più recondita e veritiera del proprio essere, perdendo i propri valori ed essendo costretto a seguire, anche a livello etico/morale, le norme dettate da altri.
1) Friedrich W. Nietzsche, Il nichilismo europeo. Frammento di Lenzerheide, Adelphi Edizioni, Milano 2006.
2 ) Per capire ciò, dobbiamo anzitutto ricordare che la filosofia ha contribuito in larga parte a fondare e perpetuare le varie
mentalità e ideologie che si sono susseguite nel corso dei secoli.
Perciò è fondamentale rivedere, secondo Nietzsche, dove e quando ebbe origine il nichilismo che condiziona la nostra
società
Detto ciò, non possiamo sapere se effettivamente l’origine del nichilismo sia la deriva filosofica socratica, tuttavia ciò che appare evidente è la sua esistenza, che si è perpetuata e susseguita – seppure
in forme diverse – durante varie fasi della storia dell’umano.
E se adesso ci chiedessimo “a oggi esiste il nichilismo?”, la mia risposta sarebbe “sì”.
Tuttavia, non lo possiamo più equiparare a quello otto-novecentesco.
Se in quel momento lo spaesamento nichilista era dovuto all’assenza improvvisa di valori a cui appigliarsi, oggi di valori ne abbiamo, fin troppi: la tecnologia e i social media si sono imposti come nuovi parametri morali ed etici, dettando il comportamento dell’umano medio, non solo occidentale ma addirittura globale.
Esiste un “però” in tutto questo: i presunti nuovi valori risultano essere completamente flessibili ma soprattutto completamente VUOTI, effimeri, spesso privi di un reale senso logico poiché legati
meramente al conformismo imperante.
Siamo in presenza di quello che potremmo definire un “omnilismo” nichilista, un bombardamento di
valori che ricomprendono tutte le condotte morali possibili, che agiscono in maniera tale da auto-escludersi a vicenda.
I ragazzi di oggi, più degli adulti, sono intrisi di “omnilismo”, poiché vivono fin dai primi istanti della loro vita questa nuova deriva nichilista: fin da piccoli i membri delle nuove generazioni faticano a trovare il loro posto nel mondo, poiché stentano in primis a reperire sé stessi, la propria essenza, al di là dei continui modelli discordanti a cui sono soggetti trovandosi di fronte ai social 24h/24.
E dunque, nello scenario moralmente apocalittico che abbiamo appena descritto, sarebbe bene cercare
ora una possibile soluzione: come fare per attraversare questo “omnilismo/nichilista” e diventare – come diceva Nietzsche – dei “nichilisti attivi”?
Essere “nichilista attivo” significa prima di tutto divenire consapevole del vivere in una società nichilista.
Io penso che questo fenomeno si possa superare solo partendo dall’educazione emotiva: a oggi la famiglia e la scuola nella maggior parte dei casi non educano emotivamente, più che altro si educa intellettualmente o fisicamente (a prendersi cura della propria salute), ma mai a riconoscere e gestire le proprie emozioni.
Detto ciò, penso che una nuova società sia possibile, cominciando a “curare” i giovani, educandoli alla conoscenza e al rispetto di sé in primis, e di conseguenza degli altri.
Ciò si può fare agendo concretamente sulla famiglia e sul sistema scolastico, partendo probabilmente dal reclutamento dei docenti: nella maggior parte dei casi, infatti, gli studenti di oggi non si trovano
in linea con metodi di insegnamento antichi e rigidamente impostati, l’insegnante tipo nella scuola italiana istruisce senza educare veramente.
Non bisogna mai dimenticare che “educare” deriva dal latino “ex-ducere” ovvero “trarre – fuori”: chi pensa di insegnare riempendo lo studente di nozioni che deve ripetere a memoria non sta davvero
educando, semmai sta istruendo.
Figure di riferimento, come genitori e insegnanti, dovrebbero anzitutto conoscere il figlio/studente per aiutarlo a conoscersi e a gestire le sue emozioni, e da ultimo a realizzare la versione migliore di
sé.
In conclusione, ritengo che il nichilismo (e quello che abbiamo qui definito “omnilismo”) si possa superare: creare dei valori propri positivi su cui costruire una società migliore diventerà possibile nel
momento in cui si opererà una reale trasformazione dello stato educativo vigente.
Di Emanuele Pestrichella e Luigi Filippo Daniele

Era il 1992 quando una squadra di magistrati, passata alla storia con il nome di “Pool mani pulite” congegnò un colpo di stato ai danni della classe dirigente. Il pool era così composto: Francesco Saverio Borrelli procuratore capo di Milano, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Tiziana Parenti, Francesco Greco, Gerardo D’Ambrosio, Antonio Di Pietro, Ilda Boccassini ed Armando Sparato.Il 17 febbraio 1992 il pubblico ministero Antonio Di Pietro decise di dare avvio all’operazione più cruenta e violenta della storia Repubblicana ai danni della classe dirigente politica.
Il pubblico ministero Di Pietro attaccò Craxi, il quale aveva la colpa di credere nel Socialismo democratico e nell’autonomia della politica dal potere giudiziario. Il Pool mani pulite non eliminò Bettino Craxi, non eliminò i partiti tradizionali, ma annientò un’intera classe dirigente, distruggendo un Paese intero e la sua fragile democrazia.La corruzione in Italia c’è sempre stata, ma la procura di Milano ed i pubblici ministeri facevano finta di non vederla, facevano finta che non esistesse. I giudici non inflissero danni solo ai partiti, inflissero fendenti letali allo stato di diritto ed alla Costituzione sostituita da una Carta materiale adeguata a leggi d’emergenza pretesa ed ottenuta dalle toghe. Mani pulite fu la spettacolarizzazione del processo, Mani Pulite fu la glamourizzazione del diritto, condita e resa possibile da un tale carabiniere-sceriffo che dopo pochi anni trovammo in Politica, prima col governo Prodi come ministro dei lavori pubblici (1996-1998) e poi dal 1998 come deputato eletto con il partito da lui creato: Italia dei Valori.
Mani pulite fu l’assalto effettuato da un pool di giudici, non ad un partito, non ad un singolo uomo, ma ad un sistema di potere creatosi nel nostro paese, un sistema democratico, per dire al Paese intero: “Adesso comandiamo noi”. Ma quel pool di pubblici ministeri grazió miracolosamente, stoppando le indagini, il PCI, che nel frattempo diventò PDS il Partito democratico della Sinistra.Concludendo la mia breve considerazione, possiamo dire che Mani Pulite fu utile alle toghe per accrescere il loro potere nei confronti della politica. Un regolamento dei conti all’interno delle classi dirigenti.I magistrati, e tutti lo sapevano, inquinavano le prove , ma nessuno li chiamò a rispondere.
Chi controlla i controllori? Ancora oggi ce lo chiediamo. Commento di Luigi Daniele
Che cosa è stata Mani Pulite e che cosa è stato Tangentopoli? Vige una differenza tra i due? Entrambi sono denominazioni coeve negli anni ’90 ma una rappresenta il nome dato alle indagini giudiziarie condotte inizialmente sull’indiziato Mario Chiesa, ingegnere e presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, dal magistrato e procuratore Antonio di Pietro e l’altro è il sistema politico amministrativo di corruzione e di tangenti che ha investito la politica italiana al fine di accaparrarsi appalti e nomine pubbliche. Era lunedì 17 febbraio 1992 ore 17:30 e un imprenditore di 32 anni, Luca Magni, si presenta in via Marostica 8 a Milano, nell’ufficio di Mario Chiesa gestore della casa di riposo per anziani (il Pio Albergo Trivulzio). Mario è un titolare di una piccola impresa di pulizie, la Ilpi di Monza, che lavora con la storica casa di ricovero per anziani, fondata nel Settecento. Chiesa è militante ed esponente del Partito Socialista Italiano e, non nascondendo le sue ambizioni politiche, sogna di diventare sindaco di Milano. Magni, dopo mezz’ora, viene ricevuto (deve consegnare 14 milioni di lire, la tangente pattuita su un appalto da 140 milioni di lire). Nel taschino della giacca ha una penna che in realtà è una microspia e stringe in mano la maniglia della valigetta che nasconde una telecamera. Magni gli dà una busta contenente 7 milioni di lire e promette che la settimana prossima darà gli altri 7 milioni.
Mentre l’imprenditore telefona a casa per tranquillizzare la madre e la sorella, che sapevano dell’operazione, una squadretta di investigatori blocca il presidente del Trivulzio che capisce di essere caduto in trappola. Quando Chiesa azzarda che i soldi erano suoi e gli investigatori replicarono all’ingegnere che quei soldi appartenevano all’ispettorato e alla procura che ha aperto le inquisizioni, egli chiede di andare in bagno, e si libera delle banconote di un’altra tangente da 37 milioni, gettandole nella tazza del gabinetto. Poi viene arrestato e portato nel carcere di San Vittore. La notizia fece scalpore, finendo sulle prime pagine dei quotidiani e venendo ripresa dai telegiornali. Il segretario socialista Bettino Craxi, allora impegnato nella campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali che si sarebbero svolte in primavera, in un’intervista rilasciata a Daniela Vergara per il TG3 negò l’esistenza della corruzione a livello nazionale, definendo Mario Chiesa un «mariuolo isolato», una scheggia impazzita dell’altrimenti integro PSI.Vista la delicata situazione politica, in piena campagna elettorale, Di Pietro mantenne sulle indagini il più assoluto riserbo. Mentre alcune formazioni politiche come la Lega Nord iniziarono a cogliere la crescente indignazione popolare per raccogliere voti (con lo slogan «Roma ladrona!»), altre, come la DC (democrazia cristiana), sottovalutarono il peso politico di Mani pulite e altri ancora come Bettino Craxi accusarono la Procura di Milano di muoversi secondo un «preciso disegno politico».Il 5 marzo 1993, il governo varò un decreto legge (il «decreto Conso», da Giovanni Conso, il Ministro della Giustizia che lo propose), che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti e definito per questo il «colpo di spugna». Il decreto, che recepiva un testo già discusso e approvato dalla commissione affari costituzionali del Senato, manteneva un «silenzio ipocrita» sul valore retroattivo della depenalizzazione, che quindi avrebbe compreso anche gli inquisiti di Mani pulite. Naturalmente, si sarebbe trattata di una retroattività scontata, essendo previsto dall’articolo 2 secondo comma del codice penale che le depenalizzazioni hanno sempre effetto retroattivo, persino se nel frattempo è già intervenuta una condanna irrevocabile.L’allarme che le inchieste di Tangentopoli rischiavano di insabbiarsi fu lanciato dal pool milanese in televisione: l’opinione pubblica e i giornali gridarono allo scandalo e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per la prima volta nella storia repubblicana rifiutò di firmare un decreto-legge, ritenendolo incostituzionale. Carlo Ripa di Meana, Ministro dell’Ambiente, diede le dimissioni dopo aver votato contro il decreto in Consiglio dei Ministri. Pochi giorni dopo, al referendum del 18 aprile 1993 (promosso dal democristiano dissidente Mario Segni), gli elettori votarono in massa a favore dell’introduzione del sistema elettorale maggioritario. Fu un segnale politico molto forte della sempre più crescente sfiducia nei confronti della politica tradizionale: il governo Amato, intravedendo nel risultato del referendum un segnale di sfiducia nei suoi confronti, rassegnò le dimissioni il 21 aprile.Il Parlamento non riuscì a formare un nuovo governo politico: Scalfaro decise perciò di affidare la presidenza del Consiglio al governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi, primo premier non politico della storia repubblicana italiana. Ciampi si pose due obiettivi fondamentali: una nuova legge elettorale che doveva essere scritta sotto dettatura del referendum (che fu poi approvata nell’agosto di quell’anno e, introducendo un sistema per tre quarti maggioritario e per un quarto proporzionale con liste bloccate, tradì in parte la volontà referendaria) e il rilancio dell’economia (che stava vivendo una difficilissima stagnazione, con la lira precipitata ai minimi storici). Malgrado questo excursus, la storia continuerebbe ma io qui mi sono limitato ad inquadrare le indagini giudiziarie, Mani Pulite, e il sistema politico amministrativo che ha rappresentato la condizione di pensabilità e di possibilità delle inchieste aperte per corruzione.
Commento di Emanuele Pestrichella
LA GUERRA E’ PACE, LA LIBERTA’ E’ SCHIAVITU’, L’IGNORANZA E’ FORZA.
di Matteo Mulè.

Inizio l’analisi del concetto di libertà, in particolar modo della “libertà di espressione” con una citazione tratta dal celebre romanzo 1984 di George Orwell, uno dei più grandi scrittori del Novecento. Orwell ha una grande capacità di creare dei mondi utopici, irreali, ma che alla fine non sono tanto distanti dalla realtà che ci circonda e che sono in grado di nascondere tutte le imperfezioni della contemporaneità.
Nel romanzo 1984 il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L’autore si sofferma con grande attenzione nel parlare del continente dell’Oceania (una probabile allusione all’Occidente odierno), la cui capitale è Londra ed è governata da questa entità astratta, ma che è costantemente presente, ovvero il Grande Fratello, che tutto sa e tutto vede.
Come ogni forza di potere, il Grande Fratello dispone di organi di controllo nei confronti della popolazione civile, che gli permettono di mantenere salda e stabile la sua posizione. Ci sono queste telecamere posizionate in tutti gli anfratti della città che analizzano ogni attimo della vita dei cittadini e sono pronte a segnalare i comportamenti sospetti alla “psicopolizia”, il braccio armato del Grande Fratello, pronta a correggere ogni anomalia del comportamento.
Ora cercherò di spiegarmi meglio, all’interno del continente dell’Eurasia le persone non vivono male, non sono povere. Tutti i cittadini dispongono di una casa, di un lavoro e di cure altamente specializzate. Insomma, il partito che governa in modo dittatoriale il continente fornisce ai cittadini tutto ciò di cui hanno bisogno ai fini della sopravvivenza, purché loro non mettano mai in discussione quanto stabilito dal Ministero della Verità. Quest’ultima è l’istituzione più forte e influente all’interno dell’Eurasia, dove tra l’altro lavora il protagonista del romanzo. Al di fuori del palazzo del Ministero della Verità (e qui, ora, mi ricollego al titolo) è inciso in una targa commemorativa, il motto del Grande Fratello: LA GUERRA È PACE, LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ, L’IGNORANZA È FORZA.
Si può notare subito che queste parole sono in antitesi tra di loro, ma riassumono perfettamente il messaggio che l’autore vuole trasmettere ai propri lettori: la verità, la realtà, la libertà sono tutti concetti opinabili, che chi è al potere può manovrare e modificare a proprio piacimento. Il Grande Fratello per poter garantire la propria sopravvivenza e quella del popolo, deve far credere ai propri cittadini che anche la guerra sia una cosa positiva, che la libertà non porti altro che alla schiavitù e che l’ignoranza sia un elemento positivo ai fini della costruzione di una società civile.
A mio parere Orwell (e questo è un mio pensiero che in nessun modo voglio far passare come verità), in 1984, non fa riferimento ad una dittatura in particolare, ma ad un insieme di elementi che si possono trovare nei vari reggimenti del passato e del presente a lui contemporaneo, di cui fanno parte anche le società di massa, sempre più tecnocratiche, dell’Occidente post Seconda Guerra Mondiale. Ora non analizzerò tutto il romanzo, perché, probabilmente, richiederebbe un trattato filosofico in termini di lunghezza e tempo, ma soprattutto credo che sia un’opera che meriti una lettura completa da parte di tutti. Quello su cui vorrei concentrarmi è la riflessione che Orwell ci offre per quanto riguarda il concetto di Verità, nel senso più ampio del temine. Ogni forma di potere, da quelle passate a quelle presenti, hanno sempre mirato al controllo della cultura e della sua trasmissione, cercando di limitare, il più possibile, la libera circolazione del pensiero e delle idee. Difatti un elemento caratteristico del Ministero della Verità è quello di imporre ai cittadini un categorico divieto: vietato pensare.
In Eurasia non ci sono libri provenienti da altri continenti, la televisione di stato trasmette incessantemente una propaganda roboante e alimenta la paura di cittadini con conflitti che, in realtà, non esistono. Ogni contenuto e ogni comportamento è passato sotto la lente d’ingrandimento del Ministero della Verità. In 1984 si ha la perfetta realizzazione di quella società tecnocratica profetizzata con timore da Heidegger e in parte attuata dalla Germania nazista, in cui gli uomini sono chiamati a rispondere al loro dovere senza provare alcun sentimento, con il fine di portare avanti la macchina statale.

Questa transizione da uomo a macchina, in cui non è più importante vivere ma sopravvivere, si sta vivendo anche nelle società Occidentali, dove un apparato tecnico ci chiede di essere sempre più efficienti ed efficaci nelle nostre scelte, tralasciando ciò che ci rallenta. La verità sul mondo che ci circonda e sui noi stessi passa in secondo piano, di fronte ai grandi problemi economici e politici che hanno sempre priorità sul resto. La letteratura, nelle sue varie forme, è l’unica possibilità che abbiamo per fermarci, riflettere senza fretta e scoprire quelle verità nascoste sul mondo e sui noi stessi, che probabilmente non servono, ma che forse ci permettono di vivere e non di sopravvivere. Esiste un antico proverbio armeno che recita così: Regala un cavallo a chi dice la verità, ne avrà bisogno per fuggire.
Bibliografia.
Calvino Italo, Lezioni americane, Mondadori, Cles, 2016.
Orwell George, 1984, traduzione italiana a cura di Stefano Manferlotti, Mondadori, Cles 2019
Note:
- George Orwell, 1984, traduzione a cura di Stefano Manferlotti, Mondadori, Cles, 2019
- Consiglio, a tal proposito, la lettura della biografia di Kurt Hubert Franz, comandante del campo di sterminio si Treblinka .
- Per un ulteriore approfondimento sul ruolo della letteratura nella contemporaneità rimando alle Lezioni Americane di Italo Calvino.
Giovani e società di massa parte 1
di Andrea Soppelsa.

Non è semplice né possibile stabilire un evento o un momento storico dal quale scaturisca o, almeno, si possa parlare di una società di massa; pertanto, è preferibile osservare tutta una serie di mutamenti che, tra il XIX secolo e l’inizio del XX, hanno condotto, nel corso di un lungo processo, alla sua nascita. La guerra franco-prussiana (1870), che modifica gli equilibri di potere nel mondo europeo, e la civil war americana (1861-1865) assieme alla enorme crescita urbana dei grandi poli (Chicago, New York, Pittsburgh, Boston), con il conseguente ingrossamento delle fila della multietnica classe operaia, sono forse i marcatori di un terminus ante quem del fenomeno. Lo sviluppo demografico, l’urbanizzazione, lo stato-nazione, l’alfabetizzazione, la comunicazione, la massificazione della partecipazione politica, le forme di associazionismo sono fenomeni che, intrecciati spesso fra di loro, segnalano la novità che Gustave Le Bon, nell’opera del 1895 Le psychologie des foules, individua nel passaggio da folle a masse. Le Bon è un antropologo che, in una temperie culturale favorevole a questo tipo di riflessioni, si occupa delle masse e della loro pericolosità, teorizzando l’importanza di controllarle per ottenere potere. Riassumere la vicenda dello sviluppo storico della società di massa comporta altresì studiare anche il mutamento dei rapporti e delle comunicazioni dei giovani, cioè di quei soggetti che nel periodo tra il XIX e il XX secolo apparvero i più propensi alla mobilitazione e, in molti casi, furono protagonisti di rivoluzioni e controrivoluzioni. Per citare un importante lavoro di Eric Hobsbawm, si potrebbe parlare di “secolo lungo” dei giovani, intendendo il periodo che va dal Risorgimento al Novecento e che, idealmente, unisce lo studente volontario garibaldino al collega che si oppone ai carri armati in piazza Tian ‘an Men.
I giovani rappresentano un gruppo sociale la cui identità è data da esperienze comuni; il passaggio alla età adulta viene fissato a livello istituzionale, conferendo all’individuo delle responsabilità giuridiche e civili, che prevedono dei requisiti come l’alfabetizzazione e l’adesione al servizio militare. Diverso il discorso per quanto riguarda la questione generazionale; definire una generazione, specie in un periodo in cui la società di massa è solo a livello embrionale, è più complesso: l’identità di una generazione si costruisce su un evento o una esperienza che dura qualche anno o qualche mese; tuttavia, tale esperienza si irradia con modalità differenti in base a fattori come l’appartenenza a una classe sociale o ad un’area geografica. A partire dalla Rivoluzione del 1789 si attesta comunemente l’idea che soltanto i giovani rappresentino una classe di età portatrice di forze progressiste e, quindi, impegnata a superare il conservatorismo della Restaurazione; Giuseppe Mazzini indica precisamente chi sono politicamente i giovani, nel momento in cui pone la soglia d’iscrizione ai movimenti della Giovine Italia e della Giovine Europa all’età di quarant’anni. I primi decenni del Novecento esaltano attraverso musica, politica e arte il mito della giovinezza, che viene associata alle idee di movimento, di modernismo e vitalismo. Molti giovani europei, pertanto, partiranno entusiasticamente a passo di marcia per il fronte nell’estate del 1914, ma ben presto conosceranno la stasi della guerra di trincea.
I fratelli minori, nel frattempo, percepiscono la frustrazione per non aver potuto partecipare alla Grande guerra; questo sentimento, perlopiù, verrà riversato nei movimenti rivoluzionari o controrivoluzionari del periodo postbellico, rendendo una generazione di giovanissimi “una classe pericolosa”, che abbisogna del paternalismo di padri e fratelli maggiori per limitarne l’autonomia. Il sacrificio dei giovani nella I guerra mondiale fa risaltare due questioni politicamente rilevanti negli anni a venire: in primo luogo, si evidenzia il nesso tra potenza di una nazione e ricchezza demografica, connessione che fa rilevare al demografo Alfred Sauvy il fatto che, confrontando la riserva umana di Germania e Francia, la nazione vinta al termine del conflitto era la seconda; quindi, e di contro, emerge il costo sociale degli anziani, che diventano un peso in quanto “bocche da sfamare”. L’idea della inutilità degli anziani affiora con la guerra, che impegna in campo lavorativo anche donne e minori, e diventa palese soprattutto a partire dal 1917, in conseguenza dello stretto razionamento alimentare. Indicatore di ciò è il numero di suicidi di anziani registrato a Parigi durante la Grande guerra. Inoltre, un processo di demansionamento degli anziani era già in atto con la dissoluzione della società rurale, nella quale essi svolgevano un fondamentale ruolo di trasmissione culturale e memoriale, che svanisce progressivamente nelle società moderne a livello comunicativo, specie nella trasmissione intergenerazionale. Un rilevante tentativo di rifuggire dalle trasformazioni sociali e ambientali dovute alla rivoluzione industriale è alla base di uno dei più interessanti movimenti giovanili nati in Germania alla fine dell’Ottocento. Si tratta dei Wandervogel, letteralmente “uccelli migratori”, un movimento apolitico e ribelle al convenzionalismo, all’autoritarismo e al paternalismo. I wandervogel davano sfogo al malessere serpeggiante nella media e alta borghesia tedesca idealizzando il culto del corpo mediante nudismo, bagni di sole e danze all’aria aperta. La questione paesaggistica nell’area tedesca (e in particolar modo le foreste), del resto, rappresentarono una sorta di fondale scenico carico di simbolismi e significati per molte organizzazioni con finalità nazionaliste, come ha ben evidenziato George Mosse nel suo lavoro La nazionalizzazione delle masse.
Anche i wandervogel a inizio secolo acuirono il proprio patriottismo e nazionalismo; molte iniziative, peraltro, erano di carattere premilitare, condotte sotto l’egida di ufficiali dell’esercito. Tuttavia, bisogna rimarcare il fatto che, benché questo tipo di associazionismo abbia certamente contribuito a creare l’humus adatto all’affermazione del totalitarismo nazionalsocialista, essi rimasero fino allo scioglimento apolitici e antiautoritari. Nel segno dell’autoritarismo era, invece, il movimento degli scout fondato da Robert Baden Powell, ufficiale inglese nella guerra anglo-boera. Egli intendeva riarmare moralmente la Gran Bretagna, arrestando la degenerazione della “razza” bianca. Pertanto, i giovani dovevano irrobustirsi e saggiare la propria virilità in una serie di prove, compresa l’esplorazione del territorio (da cui to scout). Il movimento scoutistico in Inghilterra ottenne immediatamente un larghissimo seguito, soprattutto nella prole dei nuovi ceti medi e della classe operaia qualificata dei centri urbani, che era esclusa dalle public schools e dalle altre scuole d’élite. Gli scout, in breve, si occupavano di fornire loro una sorta di pratica d’avviamento professionale. Lo scoutismo statunitense fu, invece, essenzialmente uno strumento di organizzazione del tempo libero: proprio per questo, al compimento dei 14 anni, ossia alla fine dell’età del gioco, si riteneva chiusa l’esperienza dello scout. Lo scoutismo cattolico francese rispose a una duplice necessità all’indomani della fine della guerra: ricristianizzare -attraverso i giovani- una nazione che andava secolarizzandosi e fornire dei modelli (anche autoritari e paternalistici) a una generazione lasciata senza padri. Karl Liebknecht, Ludwig Franck e Henri de Man organizzarono la nascita di un movimento transnazionale dei giovani socialisti europei: nacque così nel 1907 l’Internazionale giovanile socialista (Igs) che, fino alla guerra ebbe sede e segretario (Robert Dannenberg) viennesi. I principali obiettivi furono l’educazione, l’azione antimilitarista e la sindacalizzazione degli apprendisti. Fino al deflagrare del conflitto, gli italiani (Fgs) svolsero un ruolo marginale; nel tumultuoso biennio tra il 1914 e il 1915 innumerevoli giovani socialisti divennero interventisti al seguito di Benito Mussolini, mentre la linea della Fgs rimase neutralista e pacifista. I militanti delle federazioni giovanili socialiste furono in larghissima parte protagonisti della nascita dei partiti comunisti seguenti la Rivoluzione d’Ottobre. Nondimeno, essi produssero -forse inevitabilmente- una rottura insanabile entro la sinistra europea e, altresì, la divisione del movimento giovanile internazionale. L’adesione alla Internazionale comunista venne scelta da circa il 90% dei giovani socialisti italiani; del resto, già i rivoluzionari russi, senza tener conto del Komsomol, erano quasi tutti di età inferiore ai 40 anni. Il consenso verso i compagni sovietici andò però scemando a mano a mano che andava prefigurandosi la linea della bolscevizzazione; fu allora che molti giovani delle organizzazioni nordiche decisero di rientrare nei partiti socialdemocratici.
Molti aderenti, prevalentemente fra gli studenti, vennero perduti anche perché l’Internazionale investì nella creazione di cellule giovanili sul posto di lavoro. Anche i quadri dirigenti dei Fasci di combattimento prima e del PNF poi sono allora in larga maggioranza giovani: si tratta di una generazione che giunge trentenne o quarantenne al potere e che, vent’anni dopo, incontrerà e deluderà le aspettative di un’altra generazione (quella nata nel corso della guerra o nei primi anni del fascismo) che aspirava a svolgere un ruolo di rinnovamento in un partito che andava sclerotizzandosi. Con il bando Graziani del novembre ’43, gli italiani nati tra il 1923 e il 1925 furono chiamati a una scelta: servire la sedicente RSI oppure darsi alla clandestinità e partecipare alla lotta resistenziale. In ambe due i casi, la generazione dei primi anni Venti avrebbe finito per incontrare e fiancheggiare in questa guerra civile (come l’ha definita Claudio Pavone) un’altra generazione, da una parte quella dei fascisti della prima ora, dall’altra quella degli antifascisti che erano stati costretti all’esilio.
GIOVANI E SOCIETÀ DI MASSA. Seconda parte
di Andrea Soppelsa.
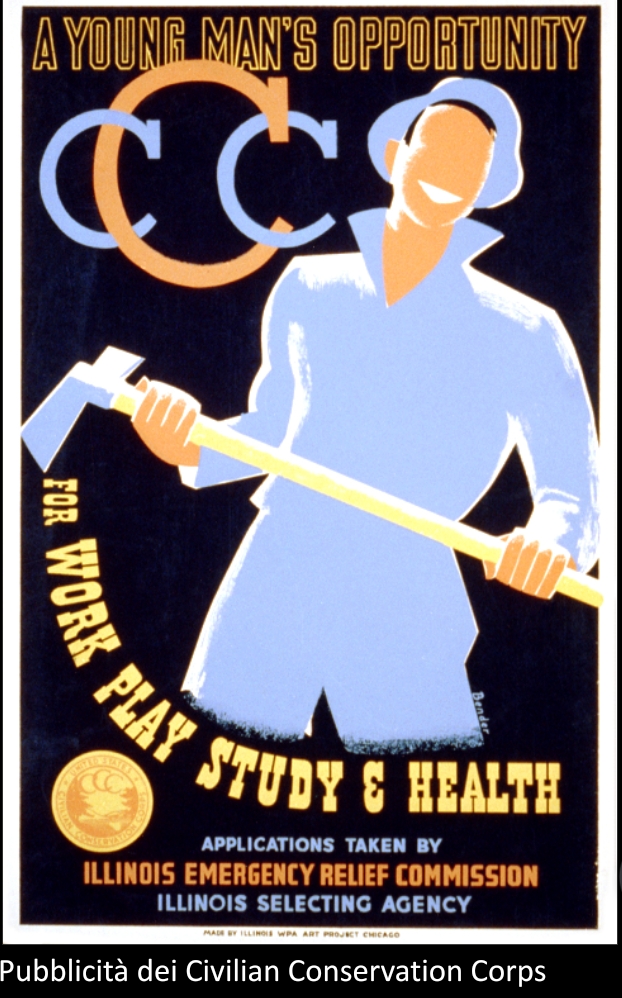
“I giovani sono il futuro” è il motto sovente utilizzato nei sistemi politici che avviano attività per organizzare le giovani generazioni. La conquista ideologica della gioventù assicura futuro e stabilità a un regime, tanto nei sistemi democratici quanto in quelli autoritari. Accade nell’Austria sconfitta della Vienna Rossa, dove manifesti e slogan propagandano l’idea di un futuro radioso e giovane, e accade anche negli USA, in cui si assiste all’afflusso disordinato di popolazione europea e asiatica e al trasferimento di popolazione, specie di ex schiavi, dagli stati del sud verso le zone industriali (come Chicago) o ancora nelle aree delle grandi fonderie (Pittsburgh) e della industria automobilistica (Detroit). Il lavoro è precario e spesso impiega anche manodopera infantile (nel 1934 erano 8 mln i bambini bisognosi di pubblica assistenza). Con l’arrivo della amministrazione Roosevelt, la questione generazionale assume rilievo mediante alcune forme di assistenza, che si prendono carico non solo della disoccupazione popolare, ma anche (ed è una novità) della disoccupazione intellettuale. Le università americane cominciano a massificarsi, ma, di converso, il sistema universitario pubblico americano non fa altro che alimentare disoccupazione intellettuale. Infatti, la popolazione studentesca statunitense ed europea nei primi decenni del XX secolo, sebbene istruita, non riesce a trovare lavoro (si veda, ad esempio, il film di Renoir, La vie est à nous). Si evidenzia anche l’attenzione per i giovani con titoli di studio, inseriti lavorativamente nei campus universitari, specialmente nella organizzazione di diverse attività di rapporto intergenerazionale. Il governo americano osserva con interesse quanto realizzato in Europa nelle politiche giovanili, in special modo le politiche fasciste. Del resto, il fascismo aspirava ad essere un modello politico originale e alternativo alle democrazie liberali; a tale riguardo, come ha recentemente notato Antonio Costa Pinto, il maggior successo fu paradossalmente riscontrato dall’esempio del corporativismo e della Carta del lavoro, emulati da molti regimi autoritari sudamericani, ma mai pienamente sviluppati nemmeno dal fascismo italiano. Per volontà di Roosevelt nascono due organi federali per la gioventù, i Civilian Conservation Corps e la National Youth Administration (che coinvolgeva anche ragazze). Grazie a questi aiuti, la durata media scolastica e la frequenza crebbero di 1/3. Tuttavia, in aree povere e rurali chiusero molte scuole, lasciando disoccupati molti insegnanti. Gli effetti del New Deal prevennero la microcriminalità -diffusa solo nelle aree in cui i programmi federali non erano stati adottati-, favorirono la diffusione della scolarizzazione e permisero di ringiovanire il corpo degli insegnanti e dei social workers. Il New Deal supera parzialmente gli effetti della crisi del ’29 ma non li risolve: il livello produttivo e il tasso di consumo non ritornano in generale ai livelli precedenti. Nel 1940 la marcia per la pace e la democrazia chiedeva lavoro e istruzione per i giovani; le manifestazioni chiedevano anche una legge contro le discriminazioni presenti nel paese. Eleanor Roosevelt fu allora una figura presente e ascoltata da giovani e sindacati, portatrice di un programma per la pace riassunto nello slogan “il nostro obiettivo è aiutare la gioventù europea ad uscire dalle trincee, e aiutare la gioventù americana a non entrare in guerra”. Pochi di coloro che avevano partecipato ai CCC (60%) nel 1940 avevano trovato occupazione. Di fatto il loro maggior successo fu forgiare il carattere e il corpo di giovani uomini, perfetti soldati per l’esercito americano nel momento della chiamata. I triple C furono campi di lavoro civile inseriti in una serie di opere di riassetto del territorio. Duravano dai 6 ai 18 mesi ed erano diffusi in tutti gli USA, allestiti dal dipartimento della guerra e dai servizi di protezione dell’ambiente. Non avevano una preparazione premilitare, ma il tempo era scandito da lavori in una vita collettiva all’aria aperta con un richiamo patriottico ai valori democratici. Lo scopo era occupare il tempo dei giovani, irrobustendo una generazione provata dalla crisi. La ferma non era obbligatoria e poteva essere interrotta in ogni momento. I campi vedono inserirsi nuovi immigrati slavi e italiani, ma anche afroamericani, che qui trovano una maggiore integrazione rispetto alla società civile.
È vero che nel dopoguerra la questione giovanile sembra scomparire dalla agenda politica federale; nondimeno, la guerra aveva portato alla ribalta la questione infantile (si pensi all’Unicef) ed apposite commissioni di stato operavano allora in collaborazione con il neocostituito ONU. Una nuova filantropia emerge con, per esempio, un rinnovato impegno svizzero per l’infanzia abbandonata. Nascono organizzazioni umanitarie, con esperienze che si replicano negli eventi di crisi; si crea una stagione di pedagogia alternativa, che s’interroga sulle modalità con cui affrontare la questione infantile per gli uomini che verranno. Sconfitto il nazifascismo, l’interesse statunitense è il containment nei confronti del comunismo: ciò avviene mediante aiuti economici e materiali. L’obiettivo è rieducare alla democrazia le giovani generazioni e salvarle dal pericolo di derive politiche e dalla pesante eredità della guerra. Ciò che avviene in Europa e in Giappone è un tentativo di defascistizzare e denazificare la popolazione mediante l’amplificazione dei processi, e -soprattutto nei sistemi scolastici- con un fenomeno di americanizzazione e, in alcuni casi, di anglicizzazione e francesizzazione (specie in Alsazia e Lorena). Giungono anche una serie di attività di leisure time legate agli occupanti: si gioca a baseball nelle aree occupate in Germania (e sono le uniche aree europee in cui questo sport ha avuto un certo successo), mentre la pallacanestro è stata solo apparentemente un portato statunitense del dopoguerra, essendo già praticata in epoca fascista. Il tempo libero legato alle culture e alle classi popolari è un tema profondamente novecentesco; in precedenza, almeno fino alla fine del XIX secolo, esso era rimasto appannaggio dei ceti altolocati. È un tempo chiaramente libero dal lavoro fisico e da altre incombenze familiari di cui godono ceti sociali legati a durate specifiche del lavoro, che tende a escludere le campagne (sebbene vi siano delle modalità associative anche di tipo rurale). Le forme di socializzazione nel Novecento non sono basate solo sulla politicizzazione, ma anche sul piacere di associarsi per svolgere attività.
L’associazionismo giovanile nel periodo compreso fra la seconda metà dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale viene indagato nel lavoro di Catia Papa “L’Italia giovane dall’Unità al fascismo”. L’obiettivo è quello di dimostrare come una cultura nazionalista, respirata sui banchi di scuola e nelle pratiche del tempo libero dei giovani borghesi, abbia condotto la gioventù colta nel 1914-15 a riversarsi nelle piazze d’Italia per forzare gli equilibri politico-istituzionali e trascinare il paese nel conflitto mondiale. Alla fine del XIX secolo, la vita media era aumentata; questo fatto aveva comportato il dilatarsi della giovinezza che, assieme ai fenomeni della deruralizzazione e urbanizzazione (con la conseguente trasformazione dei mestieri) suscitano nei ceti medi il desiderio di associazionismo giovanile. È in questo contesto che si riscopre la tradizione medievale della goliardia, spirito che anima le comunità di studenti universitari, in cui alla necessità dello studio si accompagnano il gusto della trasgressione, la ricerca dell’ironia, il piacere della compagnia e dell’avventura. Quindi, pianificare la socializzazione extrascolastica per preservare il controllo familiare sulla condotta diviene un fatto basilare al fine di neutralizzare gli impulsi eversivi e indirizzare il giovane all’apprendimento di un lavoro. Di conseguenza, appare al contempo opportuno e necessario introdurre l’etica militare nel corso degli studi. Il modello britannico del giovane atleta, lo sportman, aveva esercitato ampio fascino anche sul continente europeo, provocando una ondata di anglomania nella diffusione della pratica sportiva. Tuttavia, l’associazionismo sportivo italiano fu assai gracile, in quanto decisamente più conformista di quello tedesco (che già dal 1811 conosceva un modello di palestra all’aperto, la Turnplatz, creata da Friedrich Ludwig Jahn), più elitario di quello d’oltremanica e meno internazionale degli altri. Provarsi in ascensioni alpine alle frontiere del Regno o vogare sul Tevere, creare un circolo studentesco e mobilitarsi in favore dei “fratelli irredenti”, frequentare il tiro a segno o fondare un battaglione studentesco: sono così riassumibili i moderni esercizi di responsabilizzazione sociale e nazionale della gioventù italiana. Infine, nel 1914, la guerra apparve a questi giovani l’occasione per estrinsecare l’eroismo giovanile e rigenerare il corpo nazionale. Nel periodo interessato, il Cai (Club alpino italiano, fondato nel 1864) e la sua organizzazione giovanile, il Sucai, il Tci (Touring club italiano del 1894), la Società Dante Alighieri (dal 1889), l’Audax (1898), la Lega navale (1899), l’associazione Trento-Trieste (1902) furono le società più attive anche nel campo del tempo libero giovanile. Il sodalizio studentesco Corda fratres, che inizia le proprie attività nel 1898, si distinse fra le altre perché propagandava pace e fratellanza internazionale fra gli studenti. Essa, nondimeno, non era avulsa da intenti irredentistici, benché paventati sotto l’egida della “difesa della italianità”, specie dal pericolo pangermanico o panslavo. Nel 1902, sulle pagine della propria rivista, appare un articolo di propaganda per un ateneo italiano nelle terre irredente. È a partire da questo momento che si può affermare che l’irredentismo diviene tratto identitario del ceto studentesco, simbolo della superiore moralità della gioventù studiosa che -secondo i redattori-, ancora una volta dopo il Risorgimento, si collocava alla testa della rigenerazione nazionale. L’associazionismo studentesco milanese si sviluppò attorno alla rivista “L’Azione studentesca”, diretta da Mario Panizza, discepolo del premio Nobel per la pace Ernesto Teodoro Moneta. Il periodico, a partire dal 1907, iniziò a propugnare il riconoscimento del primato della nazione e il conseguente esercizio di solidarietà patriottica, quindi rivolse ai “volontari militi della patria” l’invocazione augurale Sursum corda!. Lo sdegno per il trattamento subito dai connazionali delle terre irredente era la modalità attraverso la quale Panizza intendeva “tenere desta” la coscienza nazionale e radicarla nell’animo della gioventù studiosa: questo era per lui il significato di irredentismo. In sostanza, si alimentava l’insofferenza verso la troppo prudente politica del governo su queste questioni, allo stesso tempo prefigurando la possibilità di una guerra contro l’impero Austro-ungarico alla quale i giovani italiani dovevano prepararsi sin dalle scuole. Fu in questo contesto che avvenne la presa di distanza di Moneta dalle idee di Panizza; il premio Nobel ribadì il fatto che il pacifismo era inconciliabile con la sostanza del programma irredentista, inevitabilmente militarista e alimento dell’”infatuazione nazionalista” di una minoranza che minacciava di imporsi sull’intero paese. Nell’ottobre 1909 la rivista “Giovinezza”, finanziata dalla Società Dante Alighieri, annunciò la nascita della Federazione dei battaglioni volontari studenteschi Sursum Corda; l’idea di creare battaglioni scolastici era già largamente diffusa fra le riviste studentesche. Del resto, nei programmi di educatori e patrioti aveva fatto capolino, a partire dalla Rivoluzione francese, la formazione ginnico-militare delle giovani generazioni, portando con sé l’ideale del cittadino-soldato, forgiato nel fisico e nello spirito al culto della patria. L’introduzione dell’educazione militare, specie del tiro a segno, venne discussa ampiamente nei decenni post-unitari; alla fine del secolo, si diffuse il timore per la “degenerazione della razza”: da tempo, infatti, i risultati delle visite di leva offrivano un quadro allarmante sulla salute fisica della popolazione maschile italiana. Scipio Sighele evocò allora lo spettro della “femminilizzazione” dei giovani italiani: i mali fisici non costituivano soltanto un problema di debolezza militare della nazione (che, in questo senso, aveva collezionato in pochi decenni umilianti sconfitte), ma anche una minacciosa fiacchezza morale che ne invalidava alle radici la virilità. Per correre ai ripari, volontari ciclisti, addestrati alle tattiche militari e al tiro a segno, già dal 1906 iniziarono a partecipare alle esercitazioni dei reggimenti e nel 1908 arrivò la legge che istituiva il Corpo nazionale volontari ciclisti e automobilisti (Vca) e a seguire il decreto che ne approvava lo statuto. Nel periodo intercorso fra la crisi bosniaca e la guerra di Libia a competere con i Vca per ottenere i favori dei giovani sorsero, in via ufficiosa, molte altre organizzazioni di volontari. In quel tempo, le società di tiro a segno avevano iniziato a offrire uno spazio in cui fanciulli sempre più piccoli iniziano a esercitarsi al “culto della santa carabina”. Nel 1909, il ministro Luigi Rava istituiva l’educazione fisica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, l’esercito entrò in ventiquattro dei quarantacinque convitti nazionali del Regno nel marzo 1910. Il variegato mondo dell’associazionismo giovanile borghese offriva la possibilità di svolgere dei grand tour, delle gite nei luoghi più significativi del Risorgimento e nelle terre contese; così facendo, si diffondeva la religione della patria. Si diffuse una sorta di “garibaldinismo di stato” consistente in una appropriazione nazionalisteggiante dell’immaginario garibaldino che si avvalse di una concezione etica della guerra, elaborata anch’essa nel corso delle lotte di liberazione. Le seducenti immagini di eroismo giovanile, il mito di un’audace minoranza che si fa carico della rivoluzione nazionale contro la gerontocrazia politica, l’alto valore morale attribuito alla prova delle armi: furono questi gli elementi intorno ai quali si andò delineando quella ideologia dell’intervento che animò le “radiose giornate” del maggio 1915. Il garibaldinismo strettamente inteso era soltanto un mito usato per suscitare l’adesione emotiva dei giovani; coltivare la tradizione garibaldina significava alimentare un patriottismo al di sopra di tutto e tutti. Al momento della guerra di Libia, però, ai battaglioni universitari venne affidato soltanto il compito di teatralizzare l’Italia giovane in armi, sfilando lungo le vie cittadine, specialmente nei quartieri popolari, e gareggiando in concorsi ginnici e di tiro. Inoltre, i militi studenti della Sursum corda e degli altri battaglioni erano totalmente soggetti al comando e alla volontà degli adulti. In tutta Europa il nesso tra virilità e nazione, tra identità maschile, esercizio delle armi e cittadinanza sorresse l’”etica della mobilitazione” della generazione del 1914. Per i giovani italiani cresciuti nei circoli patriottici e nei battaglioni volontari però non si trattò tanto o soltanto di “respirare” quei codici culturali, quanto piuttosto di esperirli quotidianamente. Nei progetti di mobilitazione bellica rientrarono soltanto i Vca e le guide alpine; infatti, i giovani delle altre associazioni studentesche vennero spinti verso la confluenza entro il locale battaglione dei Vca. Nel preparare volontariamente l’olocausto di sé, le giovani generazioni colte fornirono alla propaganda per la guerra una delle sue armi più efficaci: volere la guerra era un atto di fede nella nazione, una prova della maturità morale raggiunta dalle sue energie migliori; l’etica e l’estetica del sacrifico militare poterono più di qualsiasi distinzione partitica. Nel corso della stagione interventista il repertorio della violenza studentesca si ampliò dalle retoriche antistituzionali, dalle fischiate, dagli assalti ai consolati austriaci sino alle offensive contro i giornali e i circoli del movimento operaio, alle aggressioni ai professori tedescofili e agli esponenti politici neutralisti. Le rivendicazioni territoriali, la lotta ai nemici interni e la consapevolezza di classe costituirono gli assi portanti e fra loro correlati della mobilitazione studentesca nell’immediato dopoguerra. Nel novembre 1918, quando ripresero le agitazioni sociali, la questione adriatica rappresentò la nota dominante dell’attivismo giovanile. All’Italia dei politicanti e dei rinunciatari la gioventù studiosa opponeva il suo diritto a dettare i nuovi equilibri interni e internazionali del paese, senza peraltro mascherare il desiderio di pervenire a una risolutiva resa dei conti con gli oppositori politici.
GIOVANI E SOCIETA’ DI MASSA- PARTE TERZA
scritto da Andrea Soppelsa.

Cultura di massa e società italiana. 1936-1954 è il frutto di un ampio lavoro svolto da due storici britannici, David Forgacs e Stephen Gundle, che si sono avvalsi della oral history per fare emergere una messe di informazioni sul consumo culturale nel periodo compreso fra gli ultimi anni del regime fascista e i primi dell’Italia repubblicana. La data d’inizio è stata posta al 1936 in modo tale da comprendere la creazione del ministero della Cultura popolare (1937); quella finale, invece, è stata individuata nel 1954, anno d’inizio delle trasmissioni televisive Rai. L’obiettivo consiste nell’esaminare i rapporti tra produzione culturale, consumo e potere politico per evidenziare l’eventuale esistenza di continuità tra le attività delle industrie culturali da un lato e il consumo popolare dall’altro, in un arco cronologico frammentato in due epoche separate in termini politici. Inoltre, si voleva anche capire se vi fosse (e in che misura) continuità da parte dello stato e delle associazioni volontarie attive nella società civile nei loro rapporti con la cultura di massa. Per fare questo, gli autori, nel biennio 1991-92, hanno intervistato 117 persone tenendo conto di diverse variabili, senza la pretesa di costruire un campione rappresentativo dal punto di vista sociologico.
Il volume è suddiviso in tre parti: “Consumo culturale e vita quotidiana”, “Industrie culturali e mercati” e “Politiche e cultura di massa”. Innanzitutto, i due storici affermano che la cultura di massa operò sia a livello disintegrativo sia a livello integrativo, limitandone l’efficacia nell’opera di costruzione del consenso politico e operando una spinta sociale non sempre conservatrice. Significa, quindi, contestare o, almeno, rivedere le posizioni assunte, ad esempio, da Emilio Gentile nel suo importante lavoro Il culto del Littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista (Laterza, 1993). Per gli autori del libro, andrebbe trattata con cautela l’affermazione secondo cui il regime fascista plasmò effettivamente la mentalità degli italiani, o quantomeno li strinse in una sorta di transitoria complicità emotiva alimentando una statolatria o, nei suoi raduni di massa, un “rito di comunione”. Quest’ultimo concetto è teorizzato da Mario Isnenghi nel libro L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri (il Mulino, 2004). Nel lavoro sugli stati totalitari o autoritari, ammoniscono gli autori, si deve evitare “la fallacia metodologica” di leggere i presunti effetti di un rituale partendo dalle intenzioni dei suoi organizzatori. La storia culturale sfugge alle periodizzazioni convenzionali: il periodo fra il 1936 e il 1954 presenta continuità più significative dei cambiamenti e può essere letto come parte di un più lungo processo di modernizzazione culturale.
La cultura di massa commerciale e la diffusione delle forme di consumo culturale ad essa associate svolsero un ruolo assai rilevante nella modernizzazione dell’Italia; da una parte, creò mercati, simboli e identificazioni culturali nazionali, dall’altra, allargò la esperienza di consumatori a flussi e circuiti di comunicazione internazionali. Non si può dubitare del fatto che gli anni del miracolo economico (1958-63) siano stati un periodo di trasformazioni particolarmente rapide; tuttavia, l’impressione di una grande trasformazione compressa in un decennio, gli anni Sessanta, è ampiamente illusoria: in verità, i cambiamenti furono lenti. Molte delle testimonianze esaminate da Forgacs e Gundle restituiscono un quadro complesso ed eterogeneo; più individui ricordano alcune esperienze di prodotti culturali di massa molto tempo prima che le comunità in cui vivevano fossero abitualmente e permanentemente esposte ad essi. Per esempio, nel periodo interessato dallo studio, tre tipi di pubblicazione a stampa ebbero un pubblico di massa: la stampa sportiva, le riviste illustrate e i fumetti. Si noti che questo tipo di lettura non richiedeva alti livelli di alfabetizzazione e, a volte, poteva essere consumata anche da analfabeti che si intrattenevano guardando le foto o i disegni. “La Gazzetta dello Sport” era il quotidiano più richiesto dai detenuti (anche politici) e il più diffuso presso le milizie fasciste nella guerra di Spagna.
È, invece, più complesso stabilire con precisione il numero di lettori di libri, poiché essi godono di un ciclo vitale decisamente più longevo di quello di un quotidiano. Il cinema fu la forma più popolare di divertimento commerciale di massa in Italia, con una chiara distinzione tra centro-nord, dove si vendeva la maggior parte dei biglietti, e sud della nazione, e tra centro e periferia. L’ascesa del cinema coincise con il declino del teatro di varietà. La radio si distinse dalle altre forme di intrattenimento del periodo poiché la gente comunemente l’ascoltava mentre era intenta in altre occupazioni. Certamente, vi furono sempre più ascoltatori che abbonati: l’EIAR (Ente italiano audizioni radiofoniche) nel 1940 stimava 6 ascoltatori per ogni abbonamento privato. La diffusione della radio in Italia fu assai più contenuta numericamente rispetto ad altri paesi come la Gran Bretagna e la Germania. L’iniziale disinteresse statale unito all’elevato costo dell’apparecchio sono alla base di questo ritardo. Il fascismo, però, seppe sfruttare sin dal principio le potenzialità del mezzo: dal 1925 iniziarono ad essere trasmessi via radio i discorsi di Mussolini che, con questo espediente, nel corso del tempo, implementò la sua aura di ubiquità nella nazione. Il regime cercò di aumentare il numero degli abbonati introducendo nel commercio un modello di radio moderatamente più economico e dotando le strutture pubbliche del partito di apparecchi per l’ascolto comune.
Nel 1939-40 l’EIAR promosse un referendum sui propri programmi radiofonici; sebbene ammantato di paternalismo (si è parlato di un “plebiscito per l’EIAR” più che di un referendum), esso ci offre dei dati interessanti. Per esempio, si conferma l’irregolare distribuzione regionale, con il 73% di risposte che provengono da nord e centro. La radio fece molto per diffondere il gusto per la musica leggera: nel dopoguerra, proliferarono le sale da ballo, frequentate dalle ragazze “più emancipate”. Ballando, così come mangiando o ascoltando, gli individui assimilano i significati dei prodotti culturali che consumano, applicandoli sul proprio corpo o rendendoli visibili attraverso il comportamento.
Nelle sale cinematografiche si consumava uno dei paradossi del privato: in un contesto di rigido controllo sociale, esse rappresentavano uno dei pochissimi luoghi dove i giovani andavano in gruppo o in coppie e, nel buio della sala, potevano avere qualche contatto fisico lontano dallo sguardo dei genitori. Uomini e donne, adulti e giovani, hanno la possibilità di avere una vita privata sottratta al controllo della famiglia o del vicinato solo nello spazio pubblico: si può quindi pensare che essa sia inversamente proporzionale alla quantità di tempo che passavano nello spazio domestico. In questo periodo, tra le altre cose, la crescente visibilità dell’intimità nei cinema e negli altri luoghi pubblici fu notata con allarme dai cattolici, che, fra le varie cose, proponevano di proibire i baci sullo schermo. Forme di desiderio e individualità, che altrimenti sarebbero rimaste latenti, vennero estrinsecate proprio grazie al cinema, che offrì agli spettatori idee sulla moda e sul comportamento; secondo le testimonianze orali, un fattore da non sottovalutare è la tendenza dei genitori a opporre minor diniego verso il cinema rispetto ad altri passatempi come il ballo. Specie negli anni Trenta, ci furono molti tentativi di imitare pettinatura, trucco, portamento e modo di vestire dei divi hollywoodiani, quantunque avessero poco da spartire fisicamente con la gran parte degli italiani. I fascisti si occuparono della educazione fisica degli italiani, ma, al di là della propaganda, a livello locale le attrezzature e i luoghi per lo sport furono molto carenti. Le donne, al pari degli uomini, furono stimolate a svolgere attività fisica; ciò suscitò dibattiti e preoccupazioni. Sussistevano diverse interpretazioni del concetto di decenza per quanto concerne la “nudità” femminile in pubblico. Inoltre, i pantaloni per donne erano ritenuti un’importazione anglosassone da rigettare. Perry Willson ha sollevato la problematicità del rapporto donna-divisa nel fascismo: le camicie nere erano elemento identitario e simbolo della mascolinità guerriera che aveva conquistato al fronte il proprio diritto a determinare il destino nazionale; quindi, non si prestavano a essere indossate da donne. Tuttavia, a partire dagli anni Trenta, con la necessità di accelerare la fascistizzazione, anch’esse ottennero delle divise ufficiali, seppur private degli aspetti più virili e militaristici. L’allentamento della barriera del decoro, comunque, fu in atto già da questi anni; proprio le politiche fasciste ne furono una concausa: le località balneari, i treni popolari, il “sabato fascista”, le colonie marittime innescarono un processo lento, ma inesorabile, di sempre maggiore esposizione del corpo. Le industrie che si occupano della produzione di prodotti di massa per il tempo libero, pur dovendo sempre soggiacere a varie forme di regolazione e intervento statale, impararono ben presto a stimolare la domanda mediante la promozione e la pubblicità.
Gundle e Forgacs ritengono che nella industria culturale italiana, nonostante lo iato consumatosi nel periodo della II guerra mondiale, le strategie commerciali ideate negli anni Trenta proseguirono pressoché immutate negli anni Cinquanta per due ragioni: per prima cosa, perché le imprese culturali tendono ad agire operando con continuità, imponendo un riconoscibile “stile della casa”; secondariamente, per il fatto che l’intervento statale a livello culturale fu frammentario e, sovente, scoordinato. L’editoria rappresentava la più antica delle industrie culturali italiane; nel dopoguerra, si imposero Milano e Torino come le città capitali del mondo editoriale, mentre Firenze conobbe un rapido declino. La modernizzazione venne guidata negli anni ’30 da Mondadori e Rizzoli. Essi lanciarono le riviste di massa: nel 1940 Arnoldo Mondadori pubblicava ben nove periodici, compreso “Tempo”, emulo nostrano della celebre rivista “Life”. Mondadori si assicurò anche la licenza esclusiva dei fumetti di Walt Disney la cui pubblicazione, sebbene la dichiarazione di guerra agli USA, fu interrotta solo nel 1943 per la crisi economica. Mondadori stabilì anche una partnership con “Selezione dal Reader’s Digest”, rivista che, durante la guerra fredda, fu portatrice di una propaganda anticomunista e filoamericana, con tecniche di persuasione “soft”. Il mercato cinematografico italiano fu sempre dominato da film stranieri. Il regime fascista si rese conto dell’importanza di possedere una forte industria cinematografica nazionale per ottenere prestigio, ma, se promosse la stabilità delle società commerciali, non favorì la loro concentrazione né creò le condizioni per il loro sviluppo industriale. Nel 1937 venne inaugurata Cinecittà, i cui stabilimenti offrivano un salto qualitativo notevole in quanto a possibilità tecniche. Nel 1938 venne introdotta in Italia la legge di monopolio, la quale garantiva all’Ente nazionale italiano di cinematografia (Enic) il controllo sull’importazione di film stranieri. Le principali majors statunitensi si defilarono, boicottando il mercato italiano. Nel dopoguerra l’industria italiana del cinema soffrì il disinteresse statale, il ritorno degli americani e la distruzione del periodo bellico. Dopo molte proteste, nel 1949 venne emanata la “legge Andreotti” con cui il governo garantiva sussidi, il cui ottenimento era, però, subordinato al vaglio della sceneggiatura. Il risultato della legge innescò tre processi: l’espansione industriale, il declino dell’impegno politico e l’americanizzazione. Sorprendente effetto collaterale fu lo sviluppo di produzioni americane girate in esterni o delocalizzate in Italia. L’Italia venne trasformata in un set cinematografico ad uso degli americani, che diffusero il loro know how. Protagonisti italiani di quegli anni furono i produttori Carlo Ponti e Dino de Laurentiis che si trasferirono presto all’estero pur continuando a produrre anche in Italia. Essi furono sentimentalmente legati a Silvana Mangano e Sophia Loren, due dive italiane che in quegli anni assunsero caratura internazionale (la Loren vinse il premio Oscar come migliore attrice e la tv italiana la intervistò nel suo appartamento assieme a Carlo Ponti, il quale era molto più anziano di lei e, soprattutto, già sposato). Almeno a partire dal 1949 è stato dimostrato che la proiezione di alcuni film venne procrastinata o promossa in base al suo contenuto progressista o anticomunista. In sostanza, nella seconda metà degli anni Trenta, le industrie culturali italiane offrivano un’immagine contraddittoria: erano tecnologicamente avanzate, ma operavano in un mercato nazionale di prodotti culturali più ristretto e più povero di quello delle loro controparti che agivano in altri paesi europei. Reddito medio pro capite basso, infrastrutture di comunicazione sottosviluppate, diffuso analfabetismo, scarsa mobilità geografica: per tutte queste ragioni, la cultura era prodotta ma non ancora consumata in massa. La maggioranza dei cinema era concentrata nei centri urbani e la distribuzione dei giornali era disomogenea.
Fu soltanto la forte espansione che si registrò nella vendita di biglietti dei cinema nei primi anni del dopoguerra a convincere i vertici della RAI (così era stata ridenominata l’Eiar nel 1944) ad attivare un servizio televisivo a copertura nazionale. La televisione avrebbe grandemente contribuito a “fare gli italiani”.

STORIA E FILOSOFIA

LE RADICI STORICHE DEL LIBERALISMO
Di Emanuele Pestrichella.
Il liberalismo, a ragion veduta, non è un’ideologia perché molte volte questa ha assunto connotazioni di estremismo e di fanatismo quindi non penserò ad esso in questi termini. Credo che il liberalismo sia un indirizzo di pensiero libero (come dice la parola stessa), emancipato, non sottoponibile a influenze esterne e che sia una modalità espressiva adottata molto dalla politica, dalla filosofia, dall’economia e quindi, seguendo l’ordine, dai sistemi politici, dai sistemi filosofici e dai sistemi economici. Più propriamente se si volesse dare una definizione generale di liberalismo potremmo dire che esso è un atteggiamento etico-politico moderno tendente a concretarsi in dottrine e prassi opposte all’assolutismo e fondate essenzialmente sulla garanzia dei diritti dei cittadini da parte dello stato. Di liberalismo se ne può parlare con l’illuminismo nella rivoluzione francese, con George Washington nella rivoluzione americana con John Locke nel pensiero liberale nella filosofia moderna, con le arti cosiddette “liberali” nel medioevo ed erano due i gradi dell’insegnamento, l’uno letterario, l’altro scientifico, che comprendevano la grammatica, la retorica e la dialettica (il Trivio); l’aritmetica, la geometria, la musica, l’astronomia (il Quadrivio).
La Statua della Libertà, negli Stati Uniti d’America raffigura Libertas, la dea romana della libertà, progettata e realizzata dai francesi, che la donarono agli Stati Uniti d’America per la celebrazione della rivoluzione americana.
Nel 1790 George Washington utilizzò i termini liberale e liberalità per indicare la protezione del governo verso tutti i membri valorosi della società:
«Man mano che l’umanità diventerà più liberale, sarà più incline a permettere che tutti coloro che si comportano come membri degni della comunità abbiano uguale diritto alla protezione del governo civile. Spero di vedere l’America tra le nazioni più importanti in esempi di giustizia e liberalità»
Ma è possibile rintracciare anche una costituzione, edita il 15 giugno 1215, che tutelerà le persone ricalcando il liberalismo: parlo della solenne carta della libertà ovvero la “Magna Carta Libertatum”.
Essa era stata voluta dai baroni inglesi dopo la sconfitta della battaglia di Bouvines contro i francesi guidati da Filippo II Augusto (mentre l’esercito anglosassone era guidato da Giovanni senza terra insieme al sostegno di Ottone IV). Essa affermava che il re non poteva esigere servizi o tributi superiori a quelli pattuiti. Inoltre al sovrano era severamente vietato di imprigionare o esiliare uomini liberi senza che prima questi avesse avuto la possibilità di un regolare processo davanti ad una giuria di propri pari. Infine si faceva esplicito divieto ai funzionari reali di confiscare cavalli, carri o legname a un suddito del regno, senza il suo consenso.
Questa introduzione era finalizzata a fornire uno sguardo d’insieme a come il liberalismo è stato inteso in epoche passate, dove ha avuto origine pressappoco e, contestualizzandolo, quali significati ha assunto nelle circostanze politiche, filosofiche e culturali. Ora vorrei soffermarmi sul liberalismo inteso come pensiero politico e quali sono state le ulteriori modellizzazioni di questa forma mentis.
Il termine liberal, in senso politico, si affermò anticipatamente nel Regno Unito con l’avvento del Liberal Party, nato dalla fusione tra i whigs ed i radicals; successivamente, è stato adottato il termine old whig o liberalismo classico per differenziare la dottrina di John Locke e Adam Smith dagli orientamenti meno ortodossi del nuovo partito, quali quelli degli utilitaristi e dei radicali come John Stuart Mill.
Le trasformazioni teoriche favorite dall’evoluzione della filosofia moderna hanno portato a superare, in taluni casi, la pura concezione giusnaturalistica e ad affiancare alla difesa dei diritti politici anche quella dei diritti civili e dei diritti sociali, dando vita a nuove forme di liberalismo, con approcci diversi ai temi della democrazia, dell’egualitarismo, dello stato sociale e dell’intervento dello stato nell’economia. Il giusnaturalismo è una dottrina filosofico-giuridica ragguardevole perché vi aderì Kant, Locke e molti altri pensatori della filosofia moderna. Esso è fondato su due principi: l’esistenza di un diritto naturale (conforme cioè alla natura dell’uomo e quindi intrinsecamente giusta) e alla sua superiorità sul diritto positivo (il diritto prodotto dagli uomini).
La base ideologica, impostata con rigore logico dal filosofo contrattualista e giusnaturalista John Locke (in particolare, nel suo Il secondo trattato sul governo), propone una struttura istituzionale caratterizzata da due aspetti fondamentali:
– modellazione di tutto il sistema politico e giuridico esclusivamente sulla difesa dei diritti individuali (descritti in elenchi detti Carta dei diritti o Bill of rights), e di quelli da essi derivati in modalità deduttiva;
– scetticismo nei confronti del potere politico, da cui consegue la necessità di opporre all’arbitrio politico (cioè la violazione dei diritti individuali da parte dell’autorità pubblica) mediante strumenti istituzionali, quali un elenco scritto dei diritti inalienabili (Bill of rights ) e la separazione dei poteri;
Il radicalismo invece, altra declinazione del liberalismo, nacque in Inghilterra alla fine del XVIII secolo per indicare i sostenitori della riforma parlamentare, ed ha rappresentato l’evoluzione in senso democratico del liberalismo classico, costituendo l’ala sinistra dei partiti liberali.
La sua affermazione avvenne tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, in particolare grazie all’opera di Jeremy Bentham e John Stuart Mill.
Queste dottrine si distinguono da altre forme di liberalismo per non riconoscere la necessità di un’autorità pubblica (nel caso dell’anarco-capitalismo) o riconoscerne una ma ridotta al minimo indispensabile (nel caso del libertarianismo e del minarchismo) per la difesa dei diritti individuali.
Mentre il libertarianismo, o libertarianismo, è un insieme di filosofie politiche tra loro correlate che considerano la libertà come il più alto fine politico (ciò generalmente include la libertà individuale, la libertà politica e la libertà di associazione), il minarchismo è una filosofia politica libertariana, variatamente definita da diverse interpretazioni, ma in senso stretto abbraccia l’idea dell’esistenza di uno Stato, le cui uniche funzioni sono solo atte a legittimare la protezione degli individui da aggressioni, furti, violazioni di contratti e frodi, che le uniche funzioni governative legittime sono i militari, la polizia e le corti. In un senso più ampio, all’interno di funzioni anche quelle della protezione civile, le prigioni, i corpi esecutivi e le legislature come uniche funzioni governative legittime. Questi Stati sono generalmente definiti “Stati minimi” o “Guardiani notturni”.
BIBLIOGRAFIA
[1] «George Washington, The Providence Gazette and Country Journal, “Letter to the Roman Catholics in America,” ca. March 15, 1790, New York»
[2] «John Locke, Il secondo trattato sul governo, ca. dicembre 1689»
FILOSOFIA

COME SI PUÒ PROGREDIRE POSITIVAMENTE?
Una ricerca filosofica sulla dimensione del progresso
Di Elena Soppelsa
INTRODUZIONE
Cosa significa progresso?
Etimologicamente la parola “progresso” deriva dal latino progrēdi e significa “andare avanti”, e mai
come ora questo termine ci appartiene.
Quando sentiamo parlare di “progresso”, infatti, non possiamo fare a meno di pensare alla dimensione
tecnologica, a cui spesso e volentieri viene associato tale termine, la quale, con la sua evoluzione
continua, invade violentemente le nostre vite: siamo infatti costantemente obbligati ad adattarci e
formarci per far fronte agli avanzamenti del sistema. Chi non lo fa resta indietro inevitabilmente.
Se ci limitiamo ad analizzare il mero termine “Progredire”, questo ha normalmente un’accezione
positiva: chi non progredisce non può cambiare né migliorare.
La stessa definizione di questo termine in Treccani è: «Avanzamento in senso verticale, verso gradi
o stadi superiori, con implicito quindi il concetto del perfezionamento, dell’evoluzione, di una
trasformazione graduale e continua dal bene al meglio»(1).
Tuttavia, a volte pare che il progresso così come lo intendiamo abbia anche dei risvolti negativi; ciò
che ci chiediamo qui è dunque: il progresso è sempre positivo? Progredire è una questione più legata
alla tecnica o alla dimensione personale?
1.1. IL PROGRESSO IN SENSO TECNICO-SCIENTIFICO
I filosofi si sono spesso interrogati sull’importanza del progresso.
In particolare, Jean-Jacques Rousseau dedica ad esso un’intera opera, scritta nel 1750, intitolata
Discorso sulle scienze e sulle arti (2)
.
1 Da Progresso, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
2 Jean-Jeacques Rousseau, Discorso sulle scienze e sulle arti. Sull’origine della disuguaglianza tra gli uomni, RCS,
Milano 1997.
Secondo Rousseau, l’uomo allo stato di natura è buono, mentre, nel momento in cui viene
contaminato dalla civiltà e dalla cultura, è soggetto a corruzione.
Perciò, mentre per gli uomini attorno a lui scienza e tecnica sembrano sinonimo di miglioramento
delle condizioni umane, per il filosofo ginevrino in realtà ambedue queste dimensioni sono simbolo
di un vero e proprio danneggiamento dell’umano.
Tecnica e scienza portano gli uomini ad attribuire un’eccessiva importanza ai beni materiali, facendo
perdere il focus sulla persona umana: con il lusso del progresso tecnico diventiamo egoisti e perdiamo
di vista il bene comune.
La società perde perciò anche la sua dimensione civile e politicamente corretta: il progresso tecnico-
scientifico per Rousseau è nemico del progresso personale.
Riprendendo quindi l’analisi del filosofo illuminista, questo è probabilmente ciò che possiamo
riscontrare al giorno d’oggi con la dimensione tecnologica: i social media, simbolo di questo
cosiddetto “progresso”, risultano essere spesso simbolo di confusione, di nichilismo, che ci porta allo
spaesamento e all’abbandono della nostra stessa essenza a favore di un mondo superficiale, voluto e
creato da altri, da una classe al potere che muove i fili di questo teatro che è la realtà contemporanea.
Il progresso, se lo vediamo quindi nell’ottica tecnico-scientifica (o tecnologica), è un bene fino a un
certo punto, superato il quale diventa potenzialmente nocivo.
Frutto di questa sua nocività, quindi, sarebbe la nostra incapacità di fargli fronte: ci illudiamo di saper
gestire gli avanzamenti della tecnica, tuttavia non è così; possiamo imparare ad utilizzare i nuovi
strumenti tecnologici, ma quasi nessuno impara a gestirli a livello mentale. Con la conseguenza che
ci lasciamo travolgere da essi, come fossero lava di un vulcano in perenne eruzione.
E così ci sentiamo noi: travolti costantemente da migliaia di informazioni che ci vengono “vomitate”
addosso dai nuovi strumenti tecnologici, che siamo noi stessi a scegliere di utilizzare per stare al
passo con il sistema.
Potremmo quindi dire che questa è la nuova angoscia che affligge l’uomo moderno: mentre per
Kierkegaard l’angoscia derivava dal dover costantemente scegliere, per noi, uomini del terzo
millennio, questo sentimento significa non solo dover scegliere, ma anche essere portati a scegliere
in una confusione mentale che ci priva di ogni certezza o punto fermo, e soprattutto di cui nemmeno
siamo del tutto consapevoli.
Per questo motivo è bene riflettere sull’accostamento delle parole “progresso” e “tecnologia”: sembra
che quello tecnologico non sia un vero e proprio progresso, poiché non può garantire un
miglioramento della persona umana.
1.2. IL PROGRESSO PERSONALE
A livello personale invece, astraendo dalla scienza-tecnica, il progresso è sempre positivo?
Se dovessimo pensare all’idea di una crescita intesa nei termini del miglioramento della persona,
potremmo dire che l’emblema del progresso sta nel bambino: i primi a progredire visibilmente sono
infatti i bambini.
Il primo motivo per cui il bambino è portato a progredire più rapidamente come persona, è
probabilmente la sua ingenuità, intesa anche come una “dolce inconsapevolezza”: se ci pensate, il
bambino si prefigge mete che a noi possono sembrare impossibili, e a volte consegue dei risultati ai
nostri occhi del tutto inaspettati. E questo avviene proprio perché, non ragionando troppo sul fatto
che l’obiettivo preposto pare impossibile, egli non si pone dei limiti al suo raggiungimento. Perciò, a
differenza dell’adulto, il bambino non si sofferma sul passato o sui possibili problemi, ma
semplicemente va avanti. Questo movimento in avanti è già un progredire.
Mi viene in mente una metafora che potremmo utilizzare, tratta dallo studio dello scienziato Antoine
Magnan il quale affermò che l’insetto comunemente conosciuto come “bombo”, pur avendo una
struttura alare sproporzionata, non ne è consapevole e proprio per questo compie continuamente il
miracolo di volare3
.
Il secondo motivo a favore del progresso del bambino, è la maggiore conoscenza di sé: lo so, sembra
assurda come affermazione, ma il bambino può conoscere di sé molto più dell’adulto. Mentre noi
infatti tendiamo sempre a mettere in questione chi siamo, poiché influenzati dal clima sociale che ci
circonda, il bambino è invece molto sicuro di quale sia la sua essenza, o ancora meglio le sue
inclinazioni: se una determinata cosa piace a un bambino questi ci saprà dire subito che gli piace, allo
stesso modo, se qualcosa non è di suo gradimento, lo dirà immediatamente.
3 Tratto da Magnan Antoine, Le Vol des Insectes. Hermann, 1934.
In realtà lo stesso scienziato in seguito smentì la stessa teoria, che tuttavia rimane una metafora molto efficace della forza di
volontà dell’umano.
Noi adulti siamo spesso spaventati della semplicità, ignorando che a volte questa è l’unica via per
individuare davvero chi siamo, e così migliorare/progredire.
Detto ciò, cosa dovremmo imparare dai bambini per poter avere un maggior progresso personale?
Innanzitutto, la “visione”: per poter avanzare positivamente, abbiamo bisogno di assumere uno
sguardo proiettato al presente, ma in vista di un obiettivo futuro; ciò implica doverci liberare dai
pregiudizi che abbiamo rispetto a ciò che ci circonda, in un certo senso svuotare la mente per avere
maggiore lucidità sulla direzione da intraprendere. Questo potrebbe essere equiparato a quella che i
filosofi chiamano epoché, ovvero la “sospensione del giudizio”, che ci permette di costruire una
nuova verità, autonomamente.
In secondo luogo, per progredire personalmente dobbiamo trovare il nostro obiettivo, quello che
Socrate chiamerebbe il nostro dáimon, ovvero il “demone positivo” che ci abita, che ci indica la strada
da seguire, lo scopo ultimo della nostra esistenza.
Ognuno di noi possiede una finalità intrinseca per la quale tutto acquista un senso e che dovremmo
perseguire costantemente: solo individuando tale scopo possiamo progredire, avanzando verso il
miglioramento effettivo di noi stessi.
Il rischio è che molte volte si perda di vista o, peggio ancora, si confonda il dáimon: rincorriamo
obiettivi voluti da altri, cercando di eguagliare dei modelli. Ciò però a lungo andare si rivela essere
un regresso per la nostra persona, anziché un progresso.
Per questo è fondamentale imparare a pensare liberamente, in modo autonomo, proprio come fanno
i bambini, così da poter conoscere a fondo la nostra essenza e progredire.
Nietzsche, in merito a ciò, diceva «diventa ciò che sei»4
: l’oltre-uomo nietzschiano è proprio la
massima espressione di un uomo che ha colto appieno la propria essenza e ha deciso di portarla avanti,
fino a progredire, travalicando i confini dell’umano stesso.
Conclusioni
In conclusione, potremmo dire che il progresso vero e proprio non è da attribuire come comunemente
si crede all’evoluzione della scienza o, conseguentemente, della tecnica.
Il vero e proprio progresso è reperibile solo nell’avanzamento della persona umana.
Una persona sta progredendo quando si sta avvicinando sempre di più alla realizzazione della sua
natura peculiare, delle sue inclinazioni essenziali.
4 La citazione in questione è ripresa da un’ode di Pindaro, e ricorre più volte negli scritti nietzschiani.
Il progresso apporta qualità alla nostra vita senza toglierci qualcosa, deve essere quindi adattabile al
nostro modo di essere.
Bibliografia
– Magnan Antoine, Le Vol des Insectes. Hermann, Parigi 1934.
– Friedrich W. Nietzsche, Diventa ciò che sei: pensieri sul coraggio di essere sé stessi,
Marinotti, Milano 2006.
– Progresso, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
– Jean-Jeacques Rousseau, Discorso sulle scienze e sulle arti. Sull’origine della disuguaglianza
tra gli uomni, RCS, Milano 1997.
LETTERATURA

La macchina si è fermata a Eboli
Titolo allegorico per discutere la tematica del non-progresso e di quella “questione meridionale” che in fondo non è mai stata risolta o analizzata nella maniera più concreta. Carlo Levi, nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli, ci presenta una società, ma forse è meglio dire un mondo al di fuori del mondo stesso. Scritto tra il 1935 e il 1936, anno in cui lo scrittore ricevette il confino, il romanzo si presenta come un diario, ricco di annotazioni, di pensieri rapidi e schietti che poi sono stati riordinati qualche anno successivo e trasformati in un’opera artistica. La Lucania, quella che oggi viene chiamata Basilicata, è un mondo primitivo, semplice e violento allo stesso tempo, nel quale l’umanità è in grado, tra queste montagne rocciose e aride, di ritagliarsi un piccolo angolo per la sopravvivenza. Eboli è il paese campano dove si ferma la ferrovia, ma non solo: si ferma l’Italia. L’Italia del primo dopoguerra, che sta conoscendo un grande sviluppo industriale, sta cambiando il proprio sistema di produzione attraverso la meccanizzazione e si sta evolvendo da società agricola a industriale, conformandosi alle grandi potenze europee. Una nazione che pian piano diventa, anche se per poco tempo, una potenza coloniale, attraverso le conquiste coloniale della Libia e del Corno d’Africa. Milano, Torino e Genova sono i grandi promotori di questo progresso industriale, il quale trova la sua massima espressione nel movimento artistico e culturale del Futurismo, responsabile, quest’ultimo, della diffusione e della promulgazione di quell’ottimismo nei confronti di tutto ciò che è nuovo e si allontana dall’immobilismo della secolare tradizione italiana. Macchine, treni, aerei dipingono l’Italia degli anni ’30, ma tutto questo si ferma a Eboli, perché da lì in poi inizia un altro mondo, un’altra civiltà non collegata a quella presentata fino ad ora.
Superata Eboli l’autore si trova a dover affrontare l’ignoto, la mancanza di infrastrutture e dello Stato stesso. Arriva a Garrano grazie alla macchina di un civile, dove vi rimarrà per un paio di mesi, per proseguire con dei cavalli e verso la fine a piedi, fino a quando non si raggiunge tra le montagne di argilla il paese di Agliano (Gagliano nel romanzo, probabilmente cosi la chiamavano i locali). Lo stesso autore in una prefazione al suo romanzo scriverà: “Certo, l’esperienza intera che quel giovane (che forse ero io) andava facendo, gli rivelava nella realtà non soltanto un paese ignoto, ignoti linguaggi, lavori, fatiche, dolori, miserie e costumi, non soltanto animali e magia, e problemi antichi non risolti, e una potenza contro il potere, ma l’alterità presente, la infinita contemporaneità, l’esistenza come coesistenza, l’individuo come luogo di tutti i rapporti, e un mondo immobile di chiuse possibilità infinite […].
Gagliano viene descritto come un paese antico, di una civiltà agli arbori della sua vita. C’è un sindaco, il quale dovrebbe rappresentare lo Stato, ma anche lui conosce poco del mondo al di fuori della Lucania. Si trova a svolgere questo incarico perché è una delle poche persone del “villaggio” (a volte l’autore usa questa espressione per marcare la ruralità del posto) che è in grado di leggere e scrivere, perché ha avuto la possibilità di frequentare il ginnasio a Materia, difatti conosce anche il latino. Ma queste conoscenze hanno poca rilevanza a Gagliano. Il resto dei cittadini sono agricoltori e allevatori di capre, combattono ogni singolo giorno per sopravvivere. Non vi è un’economia vera e propria, ognuno produce quello che consuma e al massimo ci sono delle forme di baratto per ottenere dei beni che non si possiede. A Gagliano oltre alle case dei contadini ci sono due barbieri, il municipio, la stazione di polizia (formata da due brigadieri), la chiesa e un cimitero in cima ad una collina fuori del paese. Un paese bianco, una città fantasma che si anima ogni tanto per qualche rappresentazione teatrale, relativa sempre alla crudeltà della vita dei campi. Non ci sono ospedali, né mezzi di trasporto, ma esiste ancora la magia, esercitata da degli sciamani tipici delle tribù d’oltreoceano, che con i loro unguenti sono in gradi di “curare” i malanni dei contadini.
Un’altra componente che segnala da Carlo Levi è la morte, sempre presente e che accompagna la vita di tutti i giorni. I ragazzi se superano i primi anni di età è già un miracolo, per non parlare dell’alta diffusione della malaria, una malattia esotica, quasi scomparsa nel resto d’Italia, ma qui, a Gagliano, nella terra primitiva, ancora un nemico insormontabile. La presenza costante della morte permea i caratteri dei contadini, che li rende duri come la stessa terra che coltivano, togliendo pure la capacità del pianto dinnanzi alla morte dei loro cari, lasciando solamente un canto malinconico, senza speranza, di qualche donna per le strade della città. La città stessa di notte è spettrale, soprattutto quando incombono le piogge autunnali e primaverili, in grado di sciogliere quell’argilla che su cui sorge la stessa Gagliano, facendo sparire parti di città come se nulla fosse.
Le possibilità di fuga da questa povertà sono poche, ristrette ai figli di qualche antico nobile rimasto tra le campagne oppure a chi è disposto a rischiare la vita in un pericolosissimo viaggio oltreoceano verso le Americhe o ad arruolarsi per l’esercito italiano in Libia.
Ci sono anche i briganti, che a differenza di quelli del Gattopardo, non combattono contro lo Stato perché fondamentalmente non c’è, ma si limitano a piccoli furti e a qualche forma di eroismo isolato, che nessuno ricorderà.
I contadini non riconoscono l’autorità dello Stato. Questa tematica verrà sempre più messa in mostra alla fine del romanzo, in cui i contadini, opponendosi alla decisione sbagliate del sindaco, che allontanerà l’unico medico presente in paese, ovvero lo stesso Carlo Levi, organizzeranno una vera e propria protesta, affermando che lo Stato non serve, che loro si possono amministrare da soli, gettando così le basi di quelle che saranno le organizzazioni criminali del sud Italia.
Questa è Gagliano, questa è la Lucania rurale, presentata come un mondo immobile all’interno di un mondo che va avanti.
SCRITTO DA MATTEO MULE’.
Bibliografia:
Alberto Casadei, Marco Santagata, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Laterza, Roma 2007.
Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi Editore, Torino, 1975.
FILOSOFIA
PROGRESSO E SVILUPPO NELLA SOCIETÀ TARDO CAPITALISTICA

Il Progresso è una parola che caratterizza la scienza nell’ottica di ciò che è futuro, mentre il presente rimane Ricerca.
In Scritti Corsari (1) Pasolini produce una distinzione dicotomica tra sviluppo e progresso: la tecnica ( η τέχνη) non produce progresso, bensì sviluppo di disponibilità tecnica. Infatti la tecnica non ha scopi da realizzare, non ha scenari di salvezza da fare raggiungere, la tecnica è una strumentazione che tutti desiderano avere.
Il progresso si distingue dallo sviluppo perché il progresso è un miglioramento delle condizioni umane, è elevazione di stato sociale ed economico, il progresso è fare stare meglio le persone, è fare stare meglio l’Altro per antonomasia.
Ma Chi è che vuole lo sviluppo e chi è che vuole il progresso?
Secondo la distinzione pasoliniana, lo Sviluppo, concepito non quale concetto astratto e generale, ma riferito a questo sviluppo, ovvero quello posto in essere e mosso dalla società postmoderna e capitalista è voluto da una Destra economica, dagli industriali che mediante la tecnologia, applicazione della scienza, ha creato la possibilità di una industrializzazione illimitata i cui caratteri sono globali e transnazionali, e dove i consumatori di beni superflui accettano irrazionalmente questo sviluppo.
La massa dunque vive per lo sviluppo, vive in una società liquida, perché lo sviluppo permette una promozione all’interno della società della tecnica ove i singoli non sono individui ma funzionari di apparato tecnico. Lo sviluppo ha quindi sostituito il carattere strumentale dell’ideologia diventando un fatto pragmatico ed economico.
Chi è a volere il progresso? A volere il progresso sono invece gli sfruttati dal sistema capitalistico, gli operai e il proletariato che vedono nel progresso, con ingenua speranza, una nozione ideale, sociale e politica di lotta interclasse e di trasformazione della società contemporanea.
Non è detto che lo sviluppo dei mezzi tecnici costituisca automaticamente Progresso, perché può anche comportare un peggioramento della condizione dei ceti sociali.
La produzione della tecnica, o meglio delle tecniche che conducono all’efficienza dei fattori produttivi, non è per forza produzione di Felicità ( η ευδαιμονία)
È da domandarsi dunque: Che cosa Vuole la Tecnica?
Tenterei di rispondere a tale domanda con la risposta che Nietzsche si diede alla domanda “Che cosa vuole la Volontà di Potenza?” La volontà di potenza vuole solo se stessa.
Tutti noi vogliamo lo sviluppo della tecnica perché è la condizione di realizzazione di qualsiasi scopo (ο τέλος).
L’uomo vuole -ingenuamente- lo sviluppo della strumentazione universale che non coincide necessariamente però con il miglioramento delle condizioni umane.
Il sistema capitalistico aumenta le condizioni per fare crescere lo sviluppo, e tale sviluppo industriale, che tutti noi conosciamo, sta andando verso una direzione di logoramento delle risorse umane sulla Terra, lo sviluppo industriale sta de facto usurando la Terra.
Secondo Severino nel testo “il declino del Capitalismo“(2) la Tecnica eliminerà il Capitalismo.
In che modo?
Ad oggi però è veramente così?
Il Capitalismo per sopravvivere è destinato a passare dall’uso della terra alla sua usura, ma siccome la terra è il fondamento della ricchezza e la condicio sine qua non è impossibile creare profitto, e quindi il Capitale, il Capitalismo è costretto a ricorrere due Dominii: il Profitto e La Tecnica. Ci dovrà pertanto essere, auspica Severino, l’autolimitazione del profitto e del Capitalismo stesso.
La tecnica rallentando l’usura della terra costringerà il Capitalismo a depotenziarsi, anzi, a depotenziare e deincrementare la sua prepotenza e la sua arroganza(η ύβρις).
È quindi la tecnica -secondo Severino- che salvaguarderà l’umanità, creando così l’effetto autolimitativo dello sviluppo capitalistico.
Bisogna ricordare che quindi sarà necessario arrivare alla decrescita, al punto di non circondarci più di oggetti superflui, di non accumulare elementi inutili e dunque Liquidi, il che non significa rinunciare alla felicità, ma significa rinunciare a ciò di cui abbiamo meno bisogno nella convinzione di salvaguardare un bene più grande: la nostra comunità.
-la tecnica come soggetto della storia.
Il soggetto della storia non è più l’uomo come nell’ Umanesimo, non è più Dio come nel medioevo, non è più la Ragione come nell’illuminismo, bensì il soggetto della Storia è diventata la Tecnica e non nella sua accezione di “ragione strumentale”(3) all’uomo, bensì come soggetto centrale che utilizza essa stessa l’uomo come funzionario nelle mani dell’apparato tecnico.
Si ricordi che la razionalità tecnica, come tutti gli eventi culturali nella storia dell’umanità , diffonde alcuni valori permeanti: in questo caso diffonde valori quali l’efficienza e la produttività.
Marx già nel 1840 (4) scrisse una frase emblematica e che ancora ad oggi è icastica perché realizzatasi: “Tutti sono persuasi dal denaro quale mezzo per soddisfare i bisogni e produrre i beni, se il denaro diventa la condizione universale per soddisfare i bisogni per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più mezzo ma fine la cui realizzazione dipenderà solo da quanto verrá prodotto”
Karl Marx quindi già nei manoscritti economico filosofici annunciava quella che poi verrà definita “Funzione allocativa del mercato“, ovvero l’allocazione ottimale delle risorse economiche, quale efficienza della produzione dei beni che comporta sempre l’allocazione ottimale dei mezzi di produzione e quindi al massimo Profitto(5).
Se la tecnica diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo la tecnica non è più un mezzo ma è il primo scopo (ο πρώτος τέλος) che tutti desiderano, che tutti vogliono, è quindi il desiderio desiderante che desidera il soddisfacimento dell’efficienza e della produttività, unici valori perpetrati dalla società postmoderna della tecnica, perché senza quello scopo e senza il suo potenziamento tutti gli scopi diventano desideri irrealizzati.
Heidegger(6) pensa alla tecnica come svelamento delle potenzialità della natura, rientrante nella storia della verità.
Per Heidegger l’uomo non è più concepito quale individuo con una sua identità , ma l’uomo come funzionario tecnico dell’apparato sociale.
La tecnica è in mezzo a noi, modifica il nostro sentire , modifica il nostro percepire, modificherà sempre il nostro modo di pensare.
In “L’Abbandono“(7) Heidegger ci dice che inquietante non è il fatto che il mondo si traduca in apparato tecnico ma inquietante è che non ci sia nessuna consapevolezza di tale traduzione del mondo, ed ancora più inquietante è che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensare tecnico, perché nella società della tecnica il modus pensandi è quello di avvicinarsi sempre di più al pensare di un calcolatore: è fare i conti, in un mondo che gira attorno alle attività e alle passività del rendiconto e del bilancio, che sia di un’azienda o che sia dello Stato poco importa, l’uomo si sta meccanizzando e ai giorni nostri possiamo tranquillamente dire che tale previsione si è di fatto compiuta.
Siamo dunque all’interno dell’era della Tecnica, in una società postmoderna e in una società liquida(8), dove la tecnica e la tecnologia sono l’essere in divenire , l’unica costante è il cambiamento e l’unica certezza è l’incertezza del futuro.
Viviamo in una società tardo capitalistica dove il consumo è centrale, il consumismo che non mira al possesso di oggetti di desiderio in cui soddisfare il proprio desiderio, ma che rende gli oggetti di cui ci circondiamo quotidianamente completamente obsoleti, il singolo individuo così passa da un consumo all’altro in una sorta di bulimia senza scopo, anzi uno scopo c’è: il raggiungimento assoluto della tecnica.
Viviamo in una società liquida perché viviamo la convinzione che il cambiamento sia l’unica cosa permanente e che l’incertezza si l’unica certezza, in un contesto dove l’individuo -merce mercificante- diventa mero consumatore e non più soggetto centrale nella dialettica storica.
Possiamo dunque concludere che se non avverrà quanto detto da Severino, si delineerà ciò che già iniziato a delinearsi, ovvero la situazione (distopica) in cui il Progresso ha reso e renderà maggiormente inutile il lavoro di massa in relazione al volume della produzione.
Scritto da Daniele Luigi.
Note:
(1) Pasolini, Scritti Corsari 1973-1975
(2) Emanuele Severino, Declino del Capitalismo
(3) scuola di Francoforte ( Marcuse, Horkheimer, Adorno)
(4) Karl Marx, Manoscritti economico filosofici, 1844
(5)Musgrave “the theory of the public finance”
(6) Heidegger “La questione della tecnica”
(7) Heidegger “L’Abbandono “
(8)Zygmunt Baumann “Modernità Liquida” 1999
BIBLIOGRAFIA:
GALIMBERTI, L’età della tecnica e la fine della storia
Galimberti, L’uomo nell’età della tecnica 2011
Diritto e società

Populismo Penale, tra giustizialismo e garantismo.
“Il populismo giudiziario ricorre tutte le volte in cui il Magistrato pretende di assumere un ruolo di autentico rappresentante o interprete dei reali interesse e delle aspettative di giustizia del popolo, al di là della mediazione formale della legge ed altresì in una logica di supplenza se non addirittura di aperto conflitto con il potere politico ufficiale (1)
Se dovessimo dare una definizione di populismo giudiziario, potremmo fornire molteplici definizioni:
-
- il populismo penale può essere definito come la tendenza a riformare il diritto e la procedura penale in senso illiberale ed antigarantista con lo scopo di raccogliere il consenso dell’elettorato in senso demagogico, riformando il diritto penale creando “un sistema di tutela diseguale e lesivo dei diritti fondamentali” (Ferrajoli);
-
- secondo Roberts “il populismo penale consiste nel perseguimento di un insieme di politiche penali per guadagnare voti anziché ridurre i tassi di criminalità”. (2) .
-
- Secondo Cornelli, nel libro “ Contro il Panpopulismo “, il populismo penale è indirizzato a colpire gli estranei (xenos, alienus) alla comunità etica dei cittadini per bene o verso l’ élite corrotta che impediscono al popolo di essere compiutamente sovrano. Il populismo giudiziario dunque si caratterizza per la dimensione tecnica delle legislazioni e giurisdizione sostituita dalla galvanizzazione dell’opinione pubblica.
-Le Origini del populismo giudiziario.
L’origine del populismo può essere ricondotto innanzitutto in sud America. Studiosi del populismo sudamericano sono Ernest Laclau e Enrique Dussel. Anche se il termine populismo deriva dal russo ‘narodnicestvo’ designazione di un movimento di giovani intellettuali che prese forma organizzativa dopo il 1870, caratterizzato dall’idealizzazione delle masse contadine.
Secondo Laclau nel libro “Ragione Populista” il populismo è sempre stato ravvisato come un eccesso pericoloso, avendo il popolo rimpiazzato la categoria delle classi sociali e il politico in quanto tale ha integrato la costruzione del popolo stesso. La categoria ha sempre un contenuto, un concetto, direbbe Karl Marx, riprendendo un estratto del suo libro(3):<<Tutti gli economisti commettono l’errore di considerare il plusvalore non semplicemente in quanto tale [la categoria di popolo] ma nelle forme particolari di profitto e di rendita[ utilizzando tale categoria nelle sue forme derivate di populismo]>>.
Il populismo è un modo di costruire il politico, sicché in epoca contemporanea non c’è intervento politico che non sia populista.
Il populismo non è un’ideologia, ma una dimensione della cultura politica presente in movimenti diversi tra loro: è pertanto insensato tentare di identificarne i contenuti universali.
Per Laclau il populismo è soprattutto un aspetto della costruzione dell’identità sociale contemporanea in grado di condensare un’ampia varietà di antagonismi che generano specifiche richieste politiche, intese come richieste di inclusione nel sistema che, in assenza di soddisfazione, si accumulano e si trasformano in esplicite rivendicazioni: la pluralità di tali antagonismi configura il gruppo variegato di coloro che si trovano in posizione subordinata e hanno elaborato richieste di riconoscimento non soddisfatte.
A quel punto si produce una distinzione nello spazio sociale: da un lato il “noi-popolo”, dall’altro i “loro-potere”. È questo per Laclau il fondamento del populismo, che diventa tale attraverso l’elaborazione di un sistema stabile di significati collettivi in grado di mobilitare i gruppi alla ricerca di inclusione e soddisfazione. Il populismo presuppone dunque la costruzione di un’identità popolare generata dalle esclusioni sociali che vengono prodotte dal sistema sociale e politico: la convergenza delle richieste democratiche, eterogenee per definizione, produce il passaggio a una soggettività populista. Ciò è possibile soltanto se il populismo stabilisce una frontiera interna alla società tra popolo e potere, producendo così un antagonismo radicale che interroga il meccanismo della rappresentanza, fondamentale per il governo delle democrazie liberali contemporanee. In quest’ottica il populismo presenta il popolo come unico rappresentante del “tutto”, mirando alla costruzione di un’egemonia culturale attraverso la produzione di nomi, simboli e significati in grado di superare la disaggregazione dell’ordine sociale. Ed è allora per questo motivo che il populismo rappresenta più una logica politica che non un movimento, un’ideologia o un sistema di relazioni sociali.
Per Enrique Dussel il termine populismo, come Laclau, deriva dal termine “plebe” che si trasforma in “popolo”. Il popolo diventa attore collettivo , diventa popolo, inteso come “popolo per sé” quale movimento sociale, ed il nazionalismo, dice il filosofo Argentino, assume proprio questa categoria di popolo per sé cavalcando i bisogni insoddisfatti assumendo consenso.
Il concetto di popolo si origina nel momento in cui la comunità politica si scinde , perché il blocco storico al potere smette di costituire una classe dirigente, direbbe Antonio Gramsci: <<Se la classe dominante ha perduto il consenso, cioè non è più dirigente, ma unicamente dominante, detentrice della pura forza coercitiva , ciò significa che le grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali e non credono più a ciò a cui prima credevano>>(4).
Dalla perdita di consenso si incomincia a reprimere il popolo e il blocco repressore diventa classe dominante.
Il popolo per sé è l’autocoscienza del popolo che permette di diventare attore collettivo e costruttore della filosofia futura: il consenso critico del popolo come dissenso di fronte all’antico consenso divenuto ideologia di dominio mediante una prassi repressiva del blocco storico in crisi di legittimità. Il populista può essere definito come la confusione tra il proprio del popolo(blocco sociale degli oppressi) con la comunità politica per intero.
Il populismo, intendiamoci chiaro, è un fenomeno sociale, frutto di una crisi della politica ma anche dell’economia e della cultura di un paese.
Il populismo, abbiamo detto, nasce prima in Russia e si evolve in Sud America bastino gli esempi di José Antonio Primo de Rivera, Peròn, , Chavez, Vargas, Pinochet, Castro, Luis Inacio Lula da Silva, caratterizzati tutti da un unica caratteristica, ovvero dall’ unione in nome di una cultura, di una comunità ovvero di una ideologia permeante.
É un fenomeno sociale che prende forma sviluppandosi attraverso una forte leadership carismatica che è al centro della battaglia che il movimento deve condurre prima per emergere e poi per conquistare il potere.
Il leader populista deve possedere la qualità di outsider esente da ogni contaminazione con il mondo politico che si propone di spazzare via per rigenerare dalle basi la comunità popolare che lo sostiene. Tale condizione di partenza deve trovare riscontro nel suo stile politico, nei suoi gesti, nei suoi comportamenti.
Il leader populista deve avere audacia e capacità di trarre gioia dagli atti di sfida, una volontà di gioia, una convinzione fanatica di avere in possesso l’unica volontà, ha un’attitudine all’odio appassionato e disprezzo del presente.
Secondo Lewis Bernard(5) il populismo <<significa, contemporaneamente, movimento verso il popolo, in favore del popolo, che fa eco al popolo, e strategia di seduzione del popolo, tentativo di irretirlo con l’adulazione per dominate meglio o conquistare il potere politico>>. Il populismo, nell’Italia come nell’Europa del ventunesimo secolo , fa coesistere in sé tanto l’idea di demo-filia quanto di demagogia inclinandosi verso una strumentalizzazione cinica del popolo.
Il populismo pertanto può essere definito come una <<corruzione ideologica della democrazia, ovvero una demopedia (Proudhon) cioè la cura di istruire ed educare il popolo, in vista di fini universalizzabili>>(6).
Il populismo penale negli anni ’90 inizia a diventare una categoria interpretativa per capire le trasformazioni in atto nelle politiche penali degli USA. Un autore, Wood William Robert nel suo libro “Punitive Populism” disse che alla base del populismo giudiziario vi è l’idea che il sostegno pubblico stesse diventando un motore fondamentale del processo pubblico e dei cicli elettorali, con il risultato di provocare il ricorso a sanzioni più afflittive e prolungate nel tempo, indipendenti dalla loro capacità di ridurre il crimine e di rimediare ai suoi Danni, è quindi la volontà di rassicurare la popolazione. La diffusione del populismo penale riflette dei cambiamenti che intervengono nella formulazione delle politiche penali e nell’amministrazione della giustizia.
Secondo il criminologo David W. Garland (7) “la politica penale ha cessato di essere delegata dagli schieramenti politici a professionisti esperti per diventare tema di primo piano nella competizione elettorale” vedendosi attuata una applicazione intransigente del diritto penale con un impegno delle iniziative legislative volte ad introdurre nuove forme di reato, inasprire il trattamento delle sanzioni, limitare il ricorso a misure alternative al carcere ed a rafforzare l’impianto punitivo del diritto penale ( Tolleranza zero applicata dal sindaco di New York Rudolph Giuliani e teorizzata da Loic Wacquant e Alessandro De Giorgi) il cosiddetto “diritto penale del nemico”.
Elemento peculiare del populismo è diventata la spettacolarizzazione del crimine e del processo penale, ad esempio In Italia la questione di Mani Pulite rappresentata dal pubblico ministero Di Pietro il quale spettacolarizzò il caso Craxi. Nel caso di Di Pietro si può parlare di “neopopulismo giustizialista” perché nelle sue dichiarazioni e nei suoi comizi si poteva riscontrare un atteggiamento ideologico che, sulla base di principi e programmi genericamente ispirati al socialismo esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori esclusivamente postivi.
John Pratt la chiama la “glamourizzazione dei media” che provoca allarme sociale ed alimenta la paura dell’opinione pubblica, incoraggiando una risposta emotiva, violenta, orientata verso un trattamento sanzionatorio più severo.
Manconi e Graziani ne “Per il tuo bene ti mozzerò la tua testa: contro il giustizialismo morale”(8) definiscono il populismo penale come “l’esasperata drammatizzazione dei crimini allo scopo di stimolare e coltivare i sentimenti di Inquietudine e Paura dell’opinione pubblica e di incoraggiare più gli stati emotivi che le attitudini critico-razionali”, tale concetto viene richiamato anche da Nicola Tranfaglia nel libro “Populismo, un carattere originale nella storia d’Italia” nel quale espone l’idea che il populismo suscita Rancore e Paura nel popolo mediante i propri discorsi demagogici.
David Garland nel suo scritto “La cultura del controllo: crimine ed ordine sociale nel mondo contemporaneo” disse che la copertura selettiva dei fatti di cronaca da parte dei mezzi di informazione di massa e la centralità che essi accordano alla prospettiva della vittima possono distorcere la percezione pubblica della criminalità , nel senso dell’enfatizzazione e drammatizzazione del fenomeno.
Una delle maggiori cause dell’avanzata populista è riconducibile alla crisi dello stato sociale ( Welfare State): da un lato la contrazione dell’intervento pubblico nella sfera economica creerebbe i presupposti della diffusa e crescente insicurezza sociale alla base della paura nella criminalità.
Una delle tecniche riconducibili al controllo in senso populista è assoggettabile alla teoria della “Tolleranza Zero” derivante dalla “teoria delle finestre rotte” ( James Wilson e Kelling).
La Tolleranza Zero è un sintagma che designa una politica criminale in riferimento ad una particolare categoria di trasgressioni, ed infatti viene applicata nelle scuole ad esempio per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti.
-Evoluzione del populismo penale. Perchè il populismo penale è funzionale al populismo politico?
Per capire l’evoluzione del populismo penale mi servirò di alcune nozioni adottate dal’ avvocato e professore di diritto penale presso l’università di Bologna Alma Mater Studiorum, Vittorio Manes ed in particolare le nozioni espresse nel suo libro(9) “Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul processo”. Il Garantismo, ovvero l’opposto del giustizialismo, non è solo il sistema di limiti del potere punitivo e di garanzia delle libertà delle persone da punizioni eccessive o arbitrarie. É un sistema di regole razionali che garantiscono l’accertamento plausibile della verità processuale: è la razionalità che non viene accettata dalla gran parte dell’opinione pubblica.
Il populismo penale diviene funzionale al populismo politico nel momento in cui vi è convergenza tra la tendenza di questo a definirsi sulla base dell’identificazione di nemici e quindi diventa il paradigma del diritto penale del nemico, infatti tutti i populisti hanno bisogno di legittimarsi mediante un nemico o attraverso più nemici: che sia la Francia, o l’Unione Europea, oppure l’Onu, oppure l’elites, i migranti, i soggetti deviati(10). L’ autoidentificazone degli eletti con il popolo sovrano, le aggressioni alle elites, razzismo, la paura per i crimini strada, l’intolleranza del dissenso , il fastidio per il pluralismo , il vittimismo permanente. Tali elementi appena enunciati sono gli elementi costituenti la logica del nemico. Ricordiamo che il populismo non conosce cittadini ma solo amici o nemici (11). Il Populismo concepisce la giustizia penale come una guerra contro il male e l’insicurezza come emergenza quotidiana che richiede di essere rappresentata, drammatizzata e spettacolarizzata. Il populismo mediatico alimenta ed interpreta il desiderio di vendetta su capri espiatori. Il populismo penale dunque configura l’irrogazione di pene come nuova e principale domanda sociale e come risposta a gran parte dei problemi politici.
Ad esempio, nella politica contro i migranti di questi ultimi anni si può riscontrare un approccio squisitamente populistico. Infatti i decreti sicurezza del Governo Conte I ha ridotto le forme di integrazione, sopprimendo il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto è stata introdotto un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPAR) e dai centri di accoglienza straordinaria di decine di migliaia di migranti.
Ad esempio la legge di estensione dei presupposti di legittima difesa dove viene soppresso il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, con l’aggiunta che in caso di violazione di domicilio tale requisito ricorre sempre, senza valutazione del giudice: l’inviolabilità del domicilio e dei beni viene anteposta all’inviolabilità della vita umana.
Ad esempio, Le politiche populiste consistenti nel perseguimento del consenso popolare attraverso violazioni dei diritti umani: il Caso Aquarius, il caso Diciotti e Sea Watch: in tali casi si sono riscontrati reati come sequestro di persona ex art 605 c.p., violazioni di norme penali sull’omissione di soccorso alla Convenzione di Asburgo 1979 che impone di operare salvataggi <<nel modo più efficace possibile>> portando i naufraghi in un porto sicuro, è stato violato il Testo Unico sull’immigrazione del 1998 che vieta i respingimenti di quanti chiedono asilo politico( art 51 Convenzione di Ginevra) nonché dei minori e delle donne incinta o nei sei mesi successivi al parto.
Il populismo quindi esaspera delle politiche che incrementano il razzismo e l’intolleranza attraverso slogan del tipo: “Prima Gli Italiani” “La pacchia è finita” “Con noi o con Putin”.
Tali politiche sono razziste e xenofobe, perché come scrisse il filosofo Michel Focault, non è la causa , ma l’effetto delle oppressioni e delle violazioni istituzionali dei diritti umani la condizione che consente le accettabilità della messa a morte di una pluralità dell’umanità.
Negli ultimi decenni ed in particolare a partire dal 1994, ma già lo si intravedeva nella politica di Craxi, c’è stato un capovolgimento delle lotte sociali: non più di chi sta in basso contro chi sta in alto, ma dei poveri contro i poverissimi, dei cittadini contro i migranti nemico contro cui scaricare rabbia e frustrazione per la crescita di povertà e disuguaglianza.
C’è stato un mutamento della società provocato dalle politiche del lavoro: crescete svalutazione del lavoro, precarizzazione dei rapporti di lavoro e la loro arbitraria differenziazione , la distruzione dell’uguaglianza dei diritti e con essa della solidarietà di classe su cui si basavano le soggettività politiche dei lavoratori e la forma delle lotte sociali.
Le politiche del 1968 avevano introdotto varie novità: lo statuto dei lavoratori L. 300/1970, il nuovo processo del lavoro ex art 409 c.p.c., la riforma della scuola e dell’ Università , la riforma dei servizi sanitari con l’introduzione del Servizio Sanitario Nazionale a seguito della l. 833/1978 emanata dal Governo Andreotti IV , il cui ministro della sanità era Anselmi Tina.
Altre riforme quali la Legge Basaglia l. 180/1978, il divorzio nel 1970, la depenalizzazione dell’aborto, la riforma dell’ordinamento penitenziario le altre riforme garantiste in materia penale hanno portato uno spostamento di potere ai ceti più deboli.
Negli anni ’80 e ’90 ci fu una controrivoluzione in questo senso , ovvero un capovolgimento tra politica ed economia, tra sfera pubblica e sfera privata. Il paradigma è cambiato, è cambiato non in una direzione di rispetto ed inclusione delle differenze , non più la lotta contro le diseguaglianze, bensì lo sviluppo di soggettività e di conflitti identitaria contro le differenze, tale condizione è figlia di un capitalismo compiuto e sfrenato che porta non all’aggregazione ma all’ iperconnessione postmoderna del soggetto strutturato in quanto ente del fenomeno.
——>Soluzioni al populismo italiano:
Non essendoci tante vie risolutive al problema del populismo italiano, oltre quella di educare la popolazione partendo dalla scuola elementare ed arrivando alle scuole superiori, introducendo tematiche che siano trasversali, facendo tutti partecipare alla vita politica e alle attività connesse ad essa, si può però offrire un analisi sintetica ed esegetica del fenomeno populista e dei movimenti connessi ad esso(12) quali Il Fronte dell’Uomo Qualunque, MSI, Lega Salvini Premier, Rifondazione comunista, Italexit, M5S e Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale, delineando delle caratteristiche omogenee dei seguaci di tali movimenti populisti :
-
- A) Il desiderio di cambiamento indeterminato;
-
- B) Desiderio di acquisire una nuova vita, una nuova rinascita o nuovi elementi di sicurezza o di orgoglio;
-
- C) di quei movimenti di massa fanno parte alcuni tipi di soggetti: i disadattati cronici: quei soggetti che, a causa di una carenza fisica o di qualche carenza mentale, non possono realizzare quanto desiderano con maggior ardore;
-
- D)Fanno parte di tali movimenti anche gli egoisti sfrenati, individui egoisti, costretti da carenze innate o da circostanze innate a perdere fiducia in se stessi;
-
- E) gli individui di maggiore e minore successo all’interno di una minoranza dedita all’assimilazione in una comunità nazionale sono i più sensibili al richiamo dei movimenti di massa proselitismi;
-
- F)la tecnica del movimento di massa proselitismo mira ad evocare nei fedeli lo stato d’animo e la forma mentis del criminale penitente;
La Legge Spazzacorrotti l.3/2019 rappresenta uno di questi paradigmi di mutamento del diritto penale, individuando una omogeneità identificativa della genericità del diritto penale del nemico tramandando un utilizzo della punibilità funzionale a legittimare chi lo propugna, dove pertanto la catarsi punitiva del reo serve come meccanismo di evidenziazione contrassegnando quali diversi i suoi promotori, per infine collocarli nell’alveo degli incontaminati dal malaffare. Con tale legge viene a crearsi un diritto penale no limits: infatti vi è un allontanamento progressivo dei canoni di offensività ed extrema Ratio o una dicotomia dei principi di ragionevolezza e proporzione.
Un’altro elemento caratterizzante il populismo penale è rappresentato dalla politica schizofrenica ed incompetente dell’esecutivo guidato dal signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: mi sto riferendo in particolare al decreto Rave Party d.l 162/2022 il quale introduce l’art 434 bis c.p. con lo scopo di colpire chiunque “realizzi un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, da cui possa nascere un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica”.
Tale disposizione si caratterizza per una descrizione tautologica del fatto penalmente rilevante, per la violazione dei criteri di tassatività e determinatezza dal momento in cui non si determina come e quando si realizza un pericolo per l’ordine pubblico, per l’incolumità pubblica o per la salute pubblica.
La norma si presenta quale reato di pericolo concreto a dolo specifico nel quale si delinea una indefinitezza delle condotte penalmente rilevanti in quanto potrebbero comportare una ibernazione delle libertà e dei diritti fondamentali.
Gli organizzatori e i promotori sono puniti con la reclusione dai 3 ai 6 anni e con la multa dai 1000 ai 10000 euro, mentre per i partecipanti la pena è diminuita di un terzo. La cornice edittale predisposta per gli autori del delitto in questione non trova alcuna giustificazione nemmeno nei reati che possono ritenersi di analoga gravità. Le pene sono elevatissime , la cornice sanzionatoria non persegue alcuna finalità deterrente , ma puramente afflittiva, lontana dai principi di extrema ratio a cui dovrebbe perseguire il diritto penale liberale. In particolare:
-
- Il massimo edittale di 6 anni consente le intercettazioni di misure coercitive, ivi inclusa la custodia cautelare in carcere;
-
- La collocazione del Titolo VI e il minimo edittale di 3 anni estendono l’arresto obbligatorio in flagranza ad opera della polizia giudiziaria.
——> L’art 5 del d.l. 162/2022 inoltre interviene sul codice antimafia estendendo l’applicabilità delle misure di prevenzione anche agli indiziati di aver commesso il nuovo reato previsto dall’art 434 bis c.p. al pari di quanto previsto per gli indiziati di reati di associazione mafiosa o di terrorismo ed in totale sfregio ai recenti moniti di proporzionalità pronunciati dalla Corte Costituzionale.
Viene a manifestarsi un sistema di di diritto penale che è centrico ed ametrico, privo di misura.
Un diritto Penale che si sta allontanando dalla tipicità legale del reato, da ogni idea di proporzione come metro di equilibrio interno al rapporto precetto- disvalore- sanzione e come canone generale e trasversale dell’intervento punitivo, coattivo e coercitivo.
Scritto da Luigi Filippo Daniele.
NOTE E BIBLIOGRAFIA:
(1) Fiandaca, Populismo politico e giudiziario pag. 105 .
(2) Julian Roberts ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Toronto e un LLM presso l’Università di Londra. Nel 2021, è stato insignito del Sellin-Glueck Award 2021 dell’American Society of Criminology per una borsa di studio che considera la giustizia penale a livello internazionale e comparativo.
(3) Per la politica dell’economia, 1859. Karl Marx
(4) Quaderni dal carcere, 1975. Antonio Gramsci
(5) Bernard Lewis (1916-2018) storico britannico.
(6) Tranfaglia ne “Populismo. Un carattere originale nella storia d’Italia” p. 27. Roma, 2014.
(7)La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Università di Chicago, 2001.
(8) “Per il tuo bene ti mozzerò la tua testa: contro il giustizialismo morale”. 2020 Manconi e Graziani.
(9)Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul processo”. Il Mulino, Bologna 2022.
(10)Dichiarazione dei Signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una Conferenza stampa nell’ottobre del 2022.
(11) Luigi Ferrajoli in Criminalia.
(12)E. Hoffer, il vero credente. La vera natura dei movimenti di massa, Castelvecchi, Roma 2013.
Diritto Costituzionale

-
-
IL COSTITUZIONALISMO QUALE RIMEDIO AL POPULISMO LEGISLATIVO, SPIEGATO CON UNA FETTA DI TORTA
Si assuma l’esempio seguente: tre bambini dispongono di una torta ed il primo propone agli altri di dividere il tutto in tre parti uguali, affinché tutti i ragazzi possano goderne in modo identico. Gli altri due si accordano, invece, al fine di disconoscere la sua fetta del dolce, riservandosi tutta la torta e dividendone l’intero in due sole parti. Due voti sono più di uno: per questo si esige di dividere la torta in due parti eguali soltanto, lasciando insoddisfatta controparte.
ln un regime costituzionale solido, la maggioranza, per quanto schiacciante, non potrà mai privare la minoranza sconfitta della sua “fetta di torta”. La macchina, a volte mostruosa, della “volontà generale” sarebbe, per citare ROUSSEAU, padre della democrazia diretta moderna, capace di schiacciare ogni opposizione e di imporsi su tutto il popolo con la sua forza: ma intervengono dei freni poderosi, che con la loro morsa potente la arrestano. Nessuno, dunque, potrà mai essere privato senza il suo consenso della sua “fetta di torta”: ciò, in quanto esistono degli specifici valori costituzionali che riconoscono e garantiscono la posizione giuridica di ogni soggetto di diritto del nostro ordinamento.
Questi limiti sono rappresentati dalla presenza di una costituzione rigida e, in quanto tale, refrattaria ad ogni riforma normativa che neghi i diritti fondamentali dell’individuo e delle formazioni sociali ove la sua personalità si svolge. La vita democratica dello stato deve riconoscere i diritti di ogni soggetto che al suo interno si collochi: uno stato in cui chiunque può essere privato di quella fondamentale “fetta di torta” non potrebbe infatti essere definito veramente democratico.
La stessa complessa maggioranza parlamentare e popolare necessaria alla riforma costituzionale non può alterare i diritti spettanti anche ad un solo, singolo individuo, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sent. 1146/1988: i principi costituzionali fondamentali e i diritti inviolabili della persona umana, oltre a restare indisponibili al legislatore ordinario, non patiscono neppure la riforma costituzionale. I diritti umani, secondo la prospettiva di cui all’art. 2 della Costituzione repubblicana, essendo innati nell’uomo e sono dotati di un carattere pregiuridico e prepositivo, collocandosi prima della Società, della Costituzione e dello Stato, che si limitano a riconoscerli e garantirli, senza poterli rimuovere né alterare. E proprio per questo, il Nostro ordinamento costituzionale è nel suo complesso fondato sul diritto di ognuno a mangiare quella sua indispensabile “fetta di torta”.
Eppure, non di rado il legislatore, di tanto immemore e forte della propria legittimazione popolare diffusa, potrebbe spingersi ad esprimere norme di legge che di tali diritti non tengano conto: norme di legge in forza delle quali, secondo piena legalità, si pretende di strappare a quel bimbo la sua fetta di torta, in nome della maggioranza. Così il legislatore, talora afflitto dal virus del populismo legislativo, non di rado eccede in prese di posizione legislative draconiane, contro quelle categorie che volta per volta siano oggetto della pubblica critica, bersagliandole con lo strale di norme durissime e, spesso, irragionevoli: così sotto la scure furente del legislatore populista ricadono lo “straniero”, l’ “inimputabile”, il “penalmente recidivo”, il “non vaccinato”, vittime di una ferocia legislativa spesso ingiustificata.
Il farmaco necessario a eradicare un tale virus del populismo può e deve essere ricercato nella persecuzione della legalità costituzionale: è attraverso l’intervento sistematico di un soggetto che eserciti la funzione di giudice delle leggi secondo il parametro costituzionale che si potrà ricostituire la violata legalità ai sensi della Costituzione e, così, rilasciare a quel bambino la sua fetta di torta. E tale soggetto è, nell’attuale ordinamento costituzionale italiano, la Corte Costituzionale che, investita in via principale o incidentale di questioni di legittimità costituzionale della legge, ha il compito di annullare le norme illegittime restaurando l’ordo costituzionale preesistente.
Ciò in quanto, come fu per la prima volta osservato dalla corte suprema degli Stati Uniti d’America nel caso Marbury c. Madison, nessuna Costituzione veramente rigida potrebbe esistere se si permettesse al legislatore ordinario di derogarvi senza la previsione di alcun rimedio ed in difetto di un sistema di garanzia: in quanto è solo la presenza di un sistema di garanzia a rendere rigida la Costituzione, la quale – seppure nominalmente inalterata – rimarrebbe irreparabilmente esposta alla scure del legislatore.Grazie alla previsione di un intervento riparatore della Consulta, nessuno può essere privato della sua “fetta di torta”: ma è anche necessario che nessuna di queste fette sia più grande o più buona delle altre. Ciò, perché in una civiltà giuridica moderna non possono esistere diritti costituzionalmente garantiti in assoluto: per quanto la tutela degli interessi delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite rappresenti una pietra angolare (per usare il lessico della giurisprudenza costituzionale) della forma di stato democratica, l’abuso del tutto smodato ed illimitato dei diritti diviene, da garanzia di giustizia, potente veleno, capace di corrodere i fondamenti della società.
Il bilanciamento si rende, segnatamente, necessario ogniqualvolta più diritti o interessi costituzionalmente garantiti si pongano in reciproco contrasto: poiché altrimenti la garentia di una delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla Legge fondamentale finirebbe per negare in concreto tutte le altre.La garanzia di uno ius in omnia del tutto immoderato ed insuscettibile di bilanciamento con altre posizioni giuridiche determinerebbe una situazione di sistematico ed intollerabile conflitto sociale, che HOBBES definisce come bellum omnium contra omnes: uno stato di fatto di assoluto disordine, nascente dall’anarchia generale e dall’incapacità dello Stato di porre limiti all’esercizio del diritto, che si trasforma inevitabilmente in abuso.
Gli unici diritti per i quali si esclude ogni forma di esclusione o limitazione in ragione del bilanciamento con altri interessi e posizioni sono il diritto alla vita e quello alla dignità personale. Pur risultando entrambi sprovvisti di espressa menzione costituzionale, questi iura connata individuali sono, però, indubbia prerogativa di tutti gli uomini semplicemente in quanto tali: la loro presenza positiva e la loro rilevanza giuridica trascendono le singole disposizioni della Legge Fondamentale, risultando deducibili dalla lettura di ciascuna norma del Nostro ordinamento, come più volte ribadito dalla Consulta.
La Corte costituzionale si assicura che ogni fetta sia tagliata nelle giuste proporzioni, attraverso il giudizio di bilanciamento costituzionale dei diritti, degli interessi e delle posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantiti: tale sindacato – adempiuto nelle forme che la dottrina statunitense denominava “balancing test” (ROSCOE POUND) e quella germanica “Abwägung” – consente al Giudice delle leggi di esercitare i poteri connessi al proprio ufficio prevenendo ogni forma di sopruso nella guisa di una indiretta violazione di taluni diritti.
Così, in difetto di un adeguato bilanciamento non v’è legge che possa esistere: perché si tratterebbe di una legge arbitraria, che negherebbe arbitrariamente a qualcuno una parte significativa della sua porzione di torta.Così, spesso l’opinione pubblica afferma che “in democrazia vince la maggioranza”: ma è davvero sempre così? Quanto vale quella “fetta di torta”? Spesso ce ne dimentichiamo.
-

Letteratura
L’origine del populismo nella Russia zarista.
La società russa della fine del XIX secolo era caratterizzata da una forte arretratezza economica e sociale. L’economia, al contrario delle grandi potenze europee, si basava ancora per la maggior parte sull’agricoltura e l’industria tardava a svilupparsi, se non in un qualche centro urbano come San Pietroburgo. I servi della gleba costituivano ancora l’85% della popolazione, mentre i nobili proprietari terrieri, che pure rappresentavano meno dell’1%, detenevano gran parte del potere economico, anche perché era quasi assente una borghesia in grado di contrastarli e in tal modo di garantire una economia più diversificata.Lo zar Alessandro II (1855-1881), in una Russia sempre più chiusa e isolata dal panorama industriale che si andava a delineare in Europa Occidentale, cercò di modernizzare il paese abolendo la servitù della gleba (1861) e istituendo gli zemstvo (1864), ovvero delle assemblee elettive provinciali, formate da membri che provenivano sia dalla nobiltà, sia dalla borghesia che dal mondo contadino. Gli zemstvo vennero creati con lo scopo di differenziare l’amministrazione locale, cercando di limitare l’influenza e il potere che avevano i nobili nel mondo contadino, anche se in realtà tale riforma non ebbe il successo sperato, dato che la nobiltà, alla fine, mantenne i propri privilegi. Fallimentare, almeno in una fase iniziale, fu la liberazione dei servi della gleba, dal momento che i contadini non avevano i mezzi finanziari per poter riscattare la terra dai nobili e quindi ritrovandosi, alla fine, a dover lavorare per loro oppure andando ad aumentare la massa di lavoratori disoccupati delle città. In questo clima di riforme inefficaci, che non fecero altro che aumentare il dissenso da parte delle classi più povere della società, si sviluppò un movimento politico di protesta chiamato “populismo”. Con il termine “populismo” si intende storicamente un movimento culturale e politico sviluppatosi in Russia nella seconda metà dell’Ottocento, che vedeva nel popolo russo e nella sua tradizionale organizzazione comunitaria la base per realizzare una società di stampo socialista e collettivista, intraprendendo, in questo modo, un percorso diverso da quello dell’Occidente capitalista. Lo scopo degli intellettuali che appartenevano al movimento, per lo più studenti, era quello di educare il popolo, al fine di sviluppare una vera e propria coscienza di classe e di attuare una rivoluzione sociale nella Russia zarista.Si andarono a creare delle vere e proprie assemblee popolari, dove gli studenti e gli intellettuali aizzavano le masse contro il potere zarista, diffondendo progetti politici quali la distribuzione delle terre ai contadini e cercando di educare la gente dei campi al senso della libertà allo spirito del socialismo, facendo leva anche sulla forte rabbia sociale del tempo. In casi estremi i movimenti populisti si indirizzarono verso vere e proprie azioni terroristiche, delle quali rimase vittima lo stesso zar Alessandro II. Gli obiettivi che questi giovani studenti si erano fissati non vennero mai raggiunti.
La nobiltà mantenne i propri privilegi e una rivoluzione vera e propria non ci fu, se non qualche sommossa a livello popolare, repressa subito nel sangue dalla guardia zarista. Il problema principale di queste masse, come segnala anche il celebre autore Dostoevskij in Delitto e castigo, è la mancanza di una coscienza di classe, di una identità, che successivamente si svilupperà con la corrente bolscevica e conseguente Rivoluzione d’ottobre. A questo si deve aggiungere il basso di livello d’istruzione e di alfabetizzazione da parte dei contadini, che li rendeva delle pedine, in alcuni casi, in mano ai politici o intellettuali che ne potevano manipolare le menti e indirizzare l’odio e le paure verso dei problemi o nemici inesistenti. Di questa esasperazione sociale seppero farne un gran uso gli ultimi due zar, ovvero Alessandro III (1881-1894) e Nicola II (1894-1917) i quali fecero leva sul nazionalismo. Dinnanzi ai problemi che affliggevano la Russia di fine Ottocento e inizio Novecento, come la mancanza di infrastrutture, di politiche economiche volte ad eliminare le malattie legate alla malnutrizione e un progresso che aveva toccato a malapena il paese, gli zar diedero colpa della situazione sociale agli ebrei oppure al “malvagio Occidente capitalista”. Guidati molte volte dalla guardia nazionale o aizzati dai politici, i cittadini e i contadini rivolsero il loro malcontento contro gli ebrei, attuando dei massacri che in Russia presero il nome di pogrom. Gli ebrei furono costretti ad emigrare verso gli Stati Uniti o negli altri paesi europei; in questo modo la Russia perse l’unica classe mercantile del proprio paese e una grande quantità di capitale.Il populismo nacque come un movimento dedito all’educazione e scolarizzazione del popolo, con l’intento di sviluppare una coscienza di classe ai contadini e una conoscenza base per non essere più sfruttati dalla classe nobiliare e favorire una più equa ripartizione delle terre, ma alla fine le masse popolari si ritrovarono alla mercé dei loro leader che indirizzarono la rabbia e il malcontento popolare verso i loro scopi politici o economici. Il popolo russo solamente con la rivoluzione d’ottobre (1917) acquisterà una prima base di coscienza di classe, anche se l’avvento al potere della figura di Stalin (1922-1953) porterà solamente ad una sostituzione della classe nobiliare con i burocrati statali, lasciando le masse popolari in miseria e sottoposte alla rigida ideologia dello Stato. BibliografiaA.Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, Rizzoli Libri S.p.A., Milano 2017, cap. 2.F. Dostoevskij, Delitto e castigo, Mondadori, Milano, 2021.Hans Rogger, La Russia pre-rivoluzionaria. 1881-1917, Bologna, il Mulino, 1992
scritto da Matteo Mulè

Storia
POPULISMO E DEMOCRAZIA
“Populismo” è un vocabolo che nell’ultimo decennio ha goduto di grande popolarità tra giornalisti e politologi; esso indica -spesso con valenza negativa- quelle forze o movimenti politici che si presentano come antistituzionali. L’abuso mediatico del concetto di populismo, che ha prodotto -per esempio- la sua cancellatura in àmbito storiografico- è rintracciabile nella grande flessibilità del termine, che aderisce indistintamente (e questa è una significativa novità) tanto a movimenti che si collocano a destra nello schieramento politico, quanto a sinistra; questa tendenza è favorita dalla ritrosia dei populisti verso la teoria, poiché essa tende a offrire delle solide basi di cultura politica, che indirizzano il partito verso un programma -più o meno definito- da attuare. La trasversalità del populismo non cancella però le differenze ontologiche tra gli schieramenti: studi recenti sul caso francese, ove negli ultimi mesi si sono contrapposti un forte e ben radicato populismo di destra (il Rassemblement National di Marine Le Pen) e un più recente populismo radicale di sinistra (la France Insoumise di Jan-Luc Melenchon) dimostrano che i votanti dei due schieramenti condividono una forte sfiducia in senso verticale, verso l’élite (da leggersi: classe dirigente), ma differiscono nei rapporti orizzontali. Si riconferma, quindi, anche all’interno dei movimenti populisti quella che Norberto Bobbio, nell’opera “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica”(1994, Donzelli), constatava essere ancora (al termine del XX secolo e dopo il fallimento del comunismo sovietico) il criterio d’individuazione più frequentemente adottato per distinguere gli schieramenti, ossia il diverso atteggiamento di fronte all’ideale dell’uguaglianza. Una distinzione riconducibile all’atteggiamento di coloro che, pur non ignorando che gli uomini sono tanto uguali che disuguali, danno maggior importanza per giudicarli e per attribuir loro diritti e doveri, a ciò che li rende uguali piuttosto che a ciò che li rende disuguali.
Gli elettori della France Insoumise ripongono fiducia nel vicinato e, allo stesso tempo, anche nei confronti dei francesi delle altre città e degli stranieri che si trovano in Francia; è su questo punto che divergono le politiche dei populisti Melenchon e Le Pen, la quale, a livello di programmi economici, è contraria alla privatizzazione dei servizi pubblici e della sicurezza sociale, una tipologia di politica economica un tempo appannaggio della sinistra. Il populismo non è, però, una invenzione recente: rispetto al passato (si pensi al Fronte dell’Uomo qualunque di Giannini, che nel dopoguerra, per breve tempo, riuscì a raccogliere una cospicua quantità di voti di ex fascisti e anticomunisti), quando forme di populismo divampavano e si spegnevano nel breve volgere di una stagione, la novità è la lunga durata di questo fenomeno politico, che sembra destinata a non interrompersi ancora. Esso ha vissuto una prima stagione in cui si è presentato nella vasta moltitudine di vocaboli etimologicamente affini; i leader populisti sono stati popolari, ovverosia emanazione del popolo (a volte reale, più spesso inventata come nei casi Renzi e Macron, presentatisi come novità quando avevano alle spalle già una lunga storia nelle istituzioni); popolana, nella misura in cui il capo si affanna a mostrarsi come “uno qualunque” (Matteo Salvini, da buon italiano, ama mostrarsi mentre mangia); infine, volgare -cioè del volgo- nei comportamenti e negli usi linguistici (i Vaffaday di Beppe Grillo). Una seconda fase incipiente sembra far volgere verso l’acculturazione istituzionale (democratica?) alcuni movimenti populisti, specie di destra, interessanti a creare le competenze necessarie a reggere nella prassi la pratica di governo; in ciò, la rapida caduta del governo Conte I (M5S-Lega) deve aver rappresentato una buona lezione. Diversamente dal passato, e questo potrebbe risultare uno degli elementi che ne costituiscono l’insolita longevità, il populismo del XX secolo ha perduto la vis antidemocratica: esso è novatore e antiestablishment nella misura in cui pretende di incarnare la vera democrazia e di farlo in nome e per il popolo. Per questo, Ilvo Diamanti e Marc Lazare hanno coniato il neologismo “popolocrazia” (Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza, 2018), per definire il governo del popolo, inteso come comunità territoriale e identitaria chiusa e autosufficiente, nuova forma -o evoluzione- della democrazia rappresentativa, che, allo stato attuale (gestita da élites), non tutelerebbe più gli interessi del popolo. Spiega Ilvo Diamanti su La Repubblica del 20 marzo 2017: “La democrazia, in Europa: si sta trasformando in “popolocrazia”. Perché il “demos”, il principio della cittadinanza, titolare di diritti e doveri, tende a venire ri-definito in “popolo”. Comunità indistinta, unita dai confini e dai nemici. I nuovi “populisti”, emersi nell’ultima fase della nostra storia, condividono, infatti, l’avversione verso i “capi”, le burocrazie”.
La legittimazione popolare, pretesa dai movimenti populisti, fa leva sulla ignoranza del cittadino medio, che non conosce i meccanismi istituzionali (si direbbe, sovente, non sa di preciso chi e cosa vota) ed è pertanto suscettibile a recepire i fallaci discorsi dei populisti, che ottengono buon seguito delegittimando figure che, anche se lo volessero, non potrebbero essere elette direttamente dal popolo, come il presidente del consiglio dei ministri e il capo dello stato nel caso della Repubblica parlamentare italiana. Ecco allora che, quando una di queste cariche agisce inopportunamente secondo i populisti, lo si attacca dicendo:” Tu non sei stato eletto”; di conseguenza, si trasmette il messaggio che al potere si trova una sorta di usurpatore, non legittimato dalla sovranità popolare a fare quello che fa. Altro elemento nuovo e assai importante nei discorsi politici è la sovranità: probabilmente a causa delle politiche neoliberali, che hanno svuotato – de facto, non de iure- i parlamenti delle loro competenze, delle discussioni, privilegiando una pratica di governo manageriale (leggasi legiferare per decreto, in un incessante stato di crisi, vuoi economica, sanitaria, migratoria et c.), ma anche per la forma istituzionale data alla Unione Europea, percepita popolarmente come tiranno governato da burocrati non eletti (!) che sottraggono la sovranità alle nazioni che ne fanno parte, i termini populismo e sovranità hanno stretto un rapporto proficuo in termini elettorali. Tutti i principali partiti che hanno frequentato la politica del populismo in Italia (M5S, Lega, Fratelli d’Italia) hanno duramente contestato l’Europa, alcuni dicendosi apertamente euroscettici o persino prefigurando la possibilità di un ritorno alla moneta nazionale, salvo poi, una volta giunti al potere, ammorbidire le proprie posizioni, per esempio assestandosi sul vecchio adagio gollista della Europa delle nazioni (FdI). Eclatante il caso di Syriza, il partito populista di sinistra capeggiato da Alexis Tsipras, che nel 2015 chiese al popolo greco con un referendum se accettare o meno le proposte dei creditori dell’UE: sebbene, la contrarietà popolare, Tsipras si vide ugualmente costretto a scendere a patti con l’UE e ad inaugurare una politica di austerità. La crisi dei prestiti subprime del 2008 ha prodotto le condizioni ideali perché, nei paesi dell’UE più in difficoltà, fiorissero movimenti politici situazionali che proponevano soluzioni semplici ai complessi problemi.
Da qui, dalla pratica di interloquire con il popolo sfoggiando un linguaggio e dei concetti semplici, spesso alla stregua di slogan pubblicitari, ha avuto inizio il cammino di partiti populisti di sinistra come Unìdas Podemos in Spagna e Syriza in Grecia, e “né di destra né di sinistra” come il Movimento 5 Stelle in Italia. Tutti questi populismi di sinistra hanno perso la propria carica eversiva trovandosi nella situazione di gestire la cosa pubblica; tutti hanno subìto scissioni e contestazioni interne. Il Movimento 5 Stelle ha visto andare in crisi la propria pretesa alterità rispetto ai partiti tradizionali, già a partire dalla poca trasparenza delle votazioni online (democrazia digitale) che dovevano essere uno strumento nuovo per far sì che tutti gli iscritti contassero egualmente a livello decisionale (sintomo anch’esso dell’avversione per il verticismo). Infine, da partito populista, quindi camaleontico perché non legato a padri o teorie ben definite, si è collocato nell’alveo della sinistra (mantenendo -diremmo, unico retaggio del passato- il veto sull’uso di quel vocabolo per descrivere le proprie posizioni).
Se il populismo di sinistra ha nel filosofo argentino Ernesto Laclau una delle figure che più di altri ha cercato di offrire una solida base teorica a questa corrente politica, il populismo di destra si appoggia a chi più di tutti in Europa con la propria pratica di governo sembra l’esempio da seguire: Viktor Orbán, politico ungherese, Primo ministro dell’Ungheria dal 2010, carica che ha anche ricoperto precedentemente tra il 1998 e il 2002. Egli, nel corso del tempo, ha plasmato uno stato autoritario, nel quale si è progressivamente assistito a un regresso dei diritti (pluralismo, libertà individuali e collettive); tutto ciò, nondimeno facendo attenzione a mantenere la forma di stato democratico, utilizzando la sussistenza della pratica elettorale come patente di democraticità. Nel caso ungherese si parla pertanto di democrazia illiberale, poiché non è possibile ancora definirlo dittatura o stato totalitario.
Rimane, infine, insoluta la questione spesso agitata da coloro che si oppongono alla politica del populismo, ossia se questo possa costituire un male mortale per la democrazia; certamente si tratta di un prodotto della democrazia, più precisamente della discrasia tra il rappresentante e i rappresentati, cioè tra le risposte date da chi è eletto per governare e i reali bisogni degli elettori, che produce un vuoto di rappresentanza occupato (anche) dai populisti. Già al più rappresentativo statista dell’Atene classe, Pericle, era chiaro che l’agone democratico conteneva le condizioni di possibilità affinché esso degenerasse, permettendo l’accesso al potere a cuoiai, fabbricanti di lampade e guerrafondai; nondimeno, egli non si sottrasse mai alla competizione imposta dalle leggi della sua città, che, immediatamente dopo la democrazia radicale periclea, conobbe, per l’appunto, la democrazia dei bottegai (del resto, la democrazia è il governo delle masse, mentre l’aristocrazia rappresenta -letteralmente- il governo dei migliori).
La risposta che oggi non è possibile dare sarà rintracciabile come prodotto delle contingenze storiche presenti e future e della reazione che le istituzioni e le leggi dei singoli stati sapranno offrire dinanzi a questa lunga onda populista.
scritto da Andrea Soppelsa.

